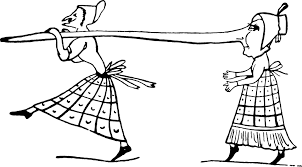Il venerdì successivo, sul tardi, ci saremmo dovuti incontrare per le prove.
Successe, però, che a metà del pomeriggio si levò un potente vento sibilante e gelido a cui seguì una nevicata memorabile come mai avevo visto. Nel giro di poco tempo tutta la città si trovò bloccata da quaranta centimetri di neve. La mia casa per diverse ore fu rischiarata dalle luci tremola, La neve proseguì per tutta la notte e il giorno successivo.
Telefonai con comodo a Tullio, a metà del mattino, tanto la vita in città era ghiacciata. Tirai un fiato di sollievo: avremmo fatto la rappresentazione dopo ben due settimane.
«Con un po’ di fortuna» pensai «il diavolo infilerà le corna un’altra volta».
Invece le forze del male non mi aiutarono e andammo in scena nella scuola di periferia secondo le previsioni.
Durante i quindici giorni che succedettero la nevicata ci vedemmo alcune volte. Tullio decise di sfrondare la Serva Padrona di molti bongiorno-bonasera, cioè dei recitativi. Pensando di possedere una grande vis comica, e perché lo spettacolo non durasse troppo poco, compensò i tagli con l’entrata di Don Magnifico dalla Cenerentola rossiniana. Il Barone di Montefiascone non si sarebbe rivolto a Clorinda e Tisbe, ma a me ed Evelina, fratellastro e sorellastra di Cenerentola, Tullio allora aggiustò i versi di Jacopo Ferretti in «Miei rampolli mascolini e femminini, vi ripudio; mi vergogno».
Provai la parte muta di Vespone con una passione proporzionale alle note che avevo da cantare. Conoscevo molto poco La Serva Padrona, avendola ascoltata dalla radio solo per quel tanto da essere pervaso di noia e cambiare il canale. Non intesi colmare le mia conoscenza dell’operina per avere dei riferimenti musicali conosciuti, così imparai l’azione e i movimenti di Vespone-Capitan Tempesta a pappagallo.
Venne finalmente il giorno della rappresentazione in una scuola al Fossolo, un sabato dopo l’Immacolata Concezione.
Ci attendevano in classe venticinque bambini educati e silenziosi, seduti compostamente davanti ai loro banchi, con indosso dei grembiulini lindi, stirati di fresco, bianchi e azzurri. Dagli sguardi curiosi e più attenti di quelli del pubblico in teatro, si percepiva che erano stati ben preparati all’ascolto dalla loro maestra, la mamma di Tullio.
Quest’attenzione mi emozionò. Si sarebbero meritati ben altro che la nostra orchestra, un registratore a musicassette appoggiato su di una sedia, e le nostre ingenue esibizioni mimiche e vocali.
L’aria di Rossini scorse via senza intoppi. All’attacco di «mie rampolli mascolini e femminini» Tullio fece il cenno di avvicinarci e ci spinse con forza a sedere per terra. E li rimanemmo. Cantò con delle belle castagne in gola, sottolineando i versi con gesti esagerati, come se avesse innanzi un pubblico di sordi.
Evelina, trovandosi a cantare in una stanza assai ampia e piena di gente, pareva più afona del solito. Nell’Intermezzo di Pergolesi entrambi si dimenarono, come sempre, con molta disinvoltura.
Fui io, invece, colui che creò l’intoppo nell’esibizione: come qualche settimana prima, andai nel pallone, dimenticando ogni cosa di quanto avevamo concordato durante le prove. Mi arrangiai ridendo come un deficiente con delle facce alla Jerry Lewis.
Non so se avvenne il consueto miracolo della Prima o se fu la fortuna che soccorre gli audaci, ma facemmo un gran successo. Al termine, i bambini accorsero tutt’intorno in festa offrendoci le delizie preparate dalle mamme, imbandite sulla cattedra della maestra prima che arrivassimo.
Mentre ci rimpinzavamo di torte di mele e al cioccolato, di pinza e ciambella pensai che non sarei mai salito su un palcoscenico con i finimenti di scena indosso. A proposito delle attitudini personali, mi venne in mente il mio professore di analisi I, al termine di un esame, quando espresse a uno studente di astronomia, con un’ efficace metafora musicale, un pensiero che lo riguardava:
«Lei mi ricorda un violinista a cui mancano le mani…Ora, non c’è nulla di male non avere le mani ma, almeno, non faccia il violinista»! Insomma,la matematica non gli si addiceva. Così detto, gli restituì il libretto senza il voto.
Il professore ebbe l’occhio fino poiché lo studente non si laureò e, dopo qualche tempo, prese a piatire per le strade del centro, a mani conserte, supplichevoli, con testa per traverso.
“La preeego, mi aiuuuti, ho faaameee, sono sfortunaaato, sono molto poooverooo”, faceva con voce che proveniva da naso.
«Anch’io sono un violinista senza mani» mi dissi mangiando gli ottimi dolci «il palcoscenico non è roba per me». Ma per questo non mi misi a mendicare.
Dopo le feste natalizie riprese il tran-tran dell’università. Mi trovai assai oberato di impegni e cose da fare perché dovevo seguire sia le lezioni universitarie che studiare per gli esami. Inoltre, devolvevo ancora qualche spicciolo di tempo libero per una moderata attività politica nell’ambito della Sezione Universitaria Comunista, la SUC, in quei giorni mobilitata per le conseguenze dell’orribile rapimento di Aldo Moro. Gli altri due, al primo anno di università, erano un po’ più liberi di me, non avendo ancora in programma alcun esame.
Di rappresentare L’Elisir d’amore in classe non se ne parlò più o forse fingemmo di dimenticarcene. Oppure perché ci sentivamo appagati dei nostri pomeriggi lirici.
Prima di conoscere Tullio ed Evelina non avevo mai pensato che la musica potesse diventare un gioco.
Il divertimento principiava con una telefonata
«Ti va una scantarellata»?
oppure
«Ci facciamo quattro strilli»?
Prendemmo gusto a duettare opere disparate, assecondando ì gusti personali di uno o dell’altro: cantammo Tosca, I Puritani, La Traviata, Rigoletto, Cavalleria Rusticana, La Boheme, La Gioconda, Otello, Il Trovatore, Il Barbiere di Siviglia, Norma, Nozze di Figaro… All’occorrenza io passavo con molta spavalderia dalla corda tenorile a quella baritonale.
Cantavamo in allegria, per divertirci, tra stonature, stecche e raspini.
Pure Evelina cantava senza remore né timori e, soprattutto, senza la bella voce della registrazione, né si sentì mai alcun suono che la ricordasse alla lontana.
Un giorno che mancò il soprano privo di voce ritornai nuovamente sulla questione della registrazione.
«Chi ti ha dato il nastro cantato da Evelina?», chiesi al mecenate di Evelina.
«Edmondo. Lo ha registrato lui».
Dall’espressione capii che la domanda non fu gradita. Una domanda inutile. Pensai che Tullio, trovandosi coinvolto in un amorazzo con Evelina, non si trovasse nella migliore condizione di ascoltare con obiettività.
Qualcuno mentiva. O Evelina, o Edmondo. E Tullio, sostenendo caparbiamente questa storia, dava il vigore della verità alla menzogna altrui.
Allorché conobbi Edmondo, lo pseudo ragazzo di Evelina – che pure era amico di Tullio – il loro triangolo alla Jules et Jim mi parve non solo una cosa fuori dalla norma rispetto ai tre soggetti, ma perfino una incomprensibile cosa, illogica.
Pensai:
«Questa ragazza è scema».
Oltre a non corrispondere in alcun modo alla corte della ragazza, si aggiungeva che Edmondo aveva veramente poco da spendere quanto a bellezza. Non che Tullio fosse un adone, ma Edmondo era proprio inavvicinabile. Come poteva pendere dalle sue labbra, contemplarlo e dirsi innamorata di lui? Aveva capelli radi, crespi, rossicci e sopracciglia unite, barba arancione a chiazze sempre di tre giorni, denti piccoli e giallastri. Non molto alto, stava in piedi con una postura ingobbita che gli faceva sparire il sedere e rientrare il petto. Sceglieva degli abiti dimessi dai colori sbiaditi, fra cui un eskimo salmastro, abiti che avrebbero intristito anche Alain Delon. Parlava con toni saccenti, una specie di grillo parlante con la erre mouillé.
Tullio riconosceva ad Edmondo una grande autorevolezza per ogni cosa. Ogni qual volta parlava del rivale-amico catechista, alzava le sopracciglia atteggiando la bocca a culo di gallina «Edmondo dice che…», «Edmondo ha fatto…», «Edmondo pensa che…». Edmondo di qua, Edmondo di là. Le registrazioni fatte da Edmondo erano le migliori. Aveva gusti musicali esemplari: Tullio odiava Wagner ma, poiché piaceva ad Edmondo, diventava il più grande musicista di tutte le epoche del mondo. Ci mancava solo che, riportando i discorsi dell’amico, concludesse con un grave «ipse dixit».
Era palese che non avrei scoperto tanto facilmente l’identità del soprano registrato e quindi, per quieto vivere, desistetti nel ricercare la verità.