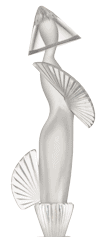«Domani, ti andrebbe d’accompagnarmi a Ferrara dalla Barioni? Ha tempo per ascoltarmi…mi farebbe una specie di audizione, insomma».
Ed io chiesi a Rufo:
«Un’audizione? All’insaputa di Mantovani? È proprio il caso di farla? Sai com’è fatto…le cose prima o poi si vengono a sapere nell’ambiente dei cantanti».
Ero perplesso. Capivo a stento quale utilità potesse avere un’audizione con un soprano senza carriera su palcoscenico. Un soprano diplomatosi a trentacinque anni, per giunta, età in cui diversi cantanti si incamminano per la via dell’irreversibile declino.
«Sì è il caso di farla», rispose Rufo indispettito, come accadeva se qualcuno avesse avuto opinioni differenti dalle sue.
E proseguì:
«Perché dovrei dirglielo? Non necessariamente Mantovani deve essere messo a conoscenza di tutto, né lo verrà mai a sapere per strade traverse. E poi, non sto mica facendo chissà che, come un’audizione con un agente teatrale, o andando da chissà chi. La Barioni è una mia compagna fuori corso. Me l’ha proposto lei. Ha piacere di sentire la mia voce. Punto e a capo». Il viaggio era definitivamente deciso.
«Insomma, vieni a Ferrara o no?».
Rufo conobbe Carmencita Romana Barioni qualche anno prima, all’Accademia di Belle Arti.
I casi della vita che l’avevano riguardata erano stati faticosi. Messa al mondo la piccola Amina Gilda, si arrabattò ad insegnare per le scuole medie del Basso Polesine dopo che il marito se ne andò senza alcuna vera, apparente, ragione. Le disse dodici parole, non una di più né una di meno.
«Devo riprendere in mano la mia vita. È tutta colpa mia…Scusatemi», questo un giorno il marito Diego le disse piangendo, mentre Carmencita Romana allattava la bambina. E questo divenne pure lo scarno racconto del suo matrimonio che Carmencita Romana ripeteva a tutti, alla madre, al prete ed anche al giudice. Senz’altre aggiunte, senz’alcun affetto, senza ricordi, mai una parola in più.
Tornò ad abitare con la madre e, divenuta professoressa di disegno in città, Carmencita Romana decise di coltivare la passione messa da parte per diverso tempo. Ricominciò, allora, a studiare canto e pianoforte con tale caparbia dedizione da essere ammessa al Conservatorio, diplomandosi nella classe di canto come soprano.
Giungemmo a Ferrara nelle prime ore del pomeriggio.
Le automobili che attraversavano Corso Giovecca si contavano sulle dita di una mano. Vedevamo solo lente biciclette. E silenziose. Ci saremmo sentiti come dentro ad una cartolina se non fosse stato per lo schioppettare dell’Opel Ascona di Rufo. Questi rumori di marmitta ci riportarono alla vita vera.
Feci un grande sforzo durante il viaggio per interessarmi alla conversazione con Rufo poiché non distolsi mai gli occhi dalle lancette del cruscotto impolverato e le orecchie dai brutti rumori prodotti da quel rosso rudere metallico.
Non so quale buona stella ci propiziò, però l’automobile non fece dei brutti scherzi. Avremmo poi avuto il problema del ritorno a Bologna. «Se quel catorcio non riparte, male che vada, prenderemo il treno».
Alla fine, avrei conosciuto questa benedetta Barioni di cui negli ultimi giorni Rufo aveva preso a parlare più volte!
«Tanto per evitare delle domande scontate…Sai che sia parente di Daniele Barioni?», il famoso tenore ferrarese che diventò uno dei tanti eredi di Enrico Caruso al Metropolitan.
«Sì gliel’ho chiesto e ha risposto che non c’entra nulla con lui. Chiamarsi Barioni a Ferrara è un po’ come chiamarsi Rossi in ogni altro luogo».
La Barioni viveva in una graziosa casetta ottocentesca a due piani tra la Certosa e il Corso Porta a Mare.
Suonato il campanello del bel portoncino verniciato di fresco, non ci aprì la Carmencita Romana.
Era un soprano. E tutti i soprani, famosi o sconosciuti, o volere o volare, fanno le primedonne. Perfino le pescivendole se cantano nel registro femminile più acuto, si trasformano in capricciose regine che fanno attendere. L’assenza nell’attesa, si sa, accresce l’aspettativa intorno all’artista, alla diva.
Una prima donna non potrà mai accogliere, fare accomodare gli ospiti, offrire loro un caffè. Dovrà necessariamente avere una segretaria, una cameriera, un servo che la serva e la riverisca.
Agli onori di casa disbrigò, quindi, la madre della Carmencita Romana, una donnina vispa sulla settantina, sorridente, vestita in grisaglia da provincia, linda e ben stirata, gradevolmente odorosa di bucato fresco e di Colonia Etrusca, acquistata alla Standa per poche lire.
«Carmencita Romana si sta preparando». Ci offrì il caffè e delle belle porzioni di zuppa inglese.
In attesa della diva, prese a parlare a ruota libera, del più e del meno, come faceva con le altre donne quand’era in attesa seduta nell’ambulatorio dal medico per farsi scrivere qualche ricetta.
Voi venite da Bologna? Che bella città! Mio fratello ha sposato proprio una bolognese. Ecco, ecco. Io invece ho sposato uno di qua. I bolognesi non dicono che i ferraresi sanno far tutto loro? A fag tot mi con ‘na man sòla. Ahahah. Ecco ecco. Il nome Carmencita Romana? Tutta farina uscita dal sacco di mio marito che dorme qui accanto. Alla Certosa. E che gli era venuto? Un colpo. Al bar mentre giocava. Non ha mica sofferto, lui. Era così bello, ma così bello durante il funerale. Pareva dormire. Meno male che almeno ho una pensione. Ecco, ecco.
Qualche istante di commozione, soffiò il naso e asciugò le lacrime con un moccichino che nascose in mezzo al seno con contegno.
«Insomma, mamma, non tediare i miei ospiti con la solita storia del babbo…son passati ormai vent’anni! Buon giorno miei cari…», irruppe nel tinello ‘la soprano’ in medias res– così Carmencita Romana diceva non per femminismo – vestita in gran pompa come per andare a un matrimonio o a un prima comunione. O forse come ‘una soprano’ da concerti in chiesa.
«Immaginati la Pagliughi, sia in volto che nel fisico… Antica, larga quanto alta, culo e tette lievitati in pochi anni come panettoni natalizi», così Rufo mi aveva già raffigurato la Barioni, durante il viaggio, con una sintesi di grande efficacia. E concluse:
«Non che prima fosse una gran bellezza…Qualunque sia stata la vera ragione per cui l’ha lasciata, potremmo concedere al marito ogni attenuante!».
«Sei stato da Codiluppi? Hai preso gli accordi per la tesi?» chiese Carmencita Romana a Rufo, con tono leggero e svagato da prima signora della città, essendosi incrociati qualche giorno prima in un corridoio dell’Accademia prima di entrare nello studiolo del professore.
«Sì, sì, l’ho visto. Progetterò le scene di un’opera…Le nozze di Figaro. Ho iniziato a buttare giù qualche schizzo. C’è tanto da fare, è un’opera complessa, tante scene, tanti personaggi, tanti costumi…».
«E lei…lei che mi racconta?», mi guardò Carmencita Romana.
«Studia canto? Vuole fare un’audizione con me?», non comprendendo appieno il motivo per cui ero lì.
«No,no, io sono solo un cantante da vasca del bagno», risposi con spirito.
«Non canta, ma è un grande amatore…», precisò Rufo.
Seguì un istante di silenzio e Carmencita Romana scoppiò in una franca risata cristallina.
«Ahaha, meglio grande amatore che grande cantante, allora…Ahaha»
E Rufo allora, compreso l’involontario doppio senso, aggiunse divertito:
«Ahaha…Volevo dire che non canta, ma conosce bene l’opera e quando una voce è buona…e ne capisce anche di tecnica!».
«Davvero? Allora lei non la racconta giusta. Si vede dalla faccia che lei è uno che ne sa…oltre ad essere un grande amatore», e accompagnò queste parole oscillando l’indice, tanto simile ad un salamino.
La soprano si rivolse quindi al tenore:
«Ruffi, suvvia, ora tocca a te, fammi sentire la voce. Che mi canti? Anzi, che ci canti?
«Lo chiama Ruffi come un barboncino da grembo? Si farà chiamare così anche in Accademia?», mi chiesi perplesso.
La scelta cadde sulla romanza di Macduff dal Macbeth verdiano.
«Sai? Non la conosco», confessò la Carmencita Romana, «ma qualunque romanza va bene per giudicare una voce…poi Verdi non si discute».
E pensai che troppo spesso i cantanti lirici pensano solamente alle loro poche note studiate, senza possedere una vera conoscenza della musica. È come pensare solo al particolare senza avere contezza del generale. Raramente si prova piacere nel parlare di musica con un cantante.
Ah, la paterna mano non vi fu scudo, o cari,
Dai perfidi sicari che a morte vi ferîr!
Terminata la romanza, Carmencita Romana esclamò con entusiasmo:
«Che bel timbro! Dolce e al contempo assai virile. La tua voce assomiglia a quella di quel tenore spagnolo…Aragall? Hai un’altra romanza da farmi sentire?»
La scelta cadde su Che gelida manina.
Ed io pensai:
«Sta’ a vedere che non conosce nemmeno la Manina!». Se fosse successo mi sarei scandalizzato.
La Barioni invece conosceva assai bene questa romanza, anche nei dettagli musicali.
«Bene, bene. Canti bene, però…devi sempre porre attenzione al legato. Scusami il bisticcio di parole: nel Belcanto, il canto deve essere bello. Il legato fa parte della bellezza. Non è questione di soli suoni fatti bene», disse al termine della Manina, sorridendo per la soddisfazione di aver detto dei grandi concetti.
L’espressione della Barioni lasciava intendere che aveva altre osservazioni. Al tenore svanì in fretta lo smagliante sorriso esibito in tutte le occasioni possibili.
«Ruffi con chi stai studiando?».
«Studio con Floriano Mantovani, un tenore comprimario del Comunale. A lui mi ha indirizzato la maestra di pianoforte», rispose Rufo.
«Sei senz’altro destinato ad una bella carriera…ma la qualità della voce non è tutto. Tecnica, tecnica, ci vuole tecnica. Con questo materiale vocale devi fare di più e meglio», disse ‘la soprano’.
Rufo ascoltò serio senza alcuna apparente reazione, senza replicare.
«Facciamo insieme dei vocalizzi?».
Mettendo insieme tutte le osservazioni che Carmencita Romana fece durante gli esercizi, mi parve di capire che Rufo dovesse rivedere molte cose.
«Perché spingi in basso? È proprio l’opposto di quanto si deve fare per cantare in maniera ortodossa. Così cantano quelli che affondano il suono, come Del Monaco…Qualche anno di palcoscenico, un po’ di soldi e dopo…addio che t’amavo! Ti troverai con la voce appesantita e ti spariranno gli acuti. Su avvicinati a me…».
Anziché spiegare a parole, cominciò a spingere sullo stomaco di Rufo con il pugno della mano destra e con l’altra saldamente lo tratteneva alle reni.
«Ora canta…In alto, in alto, devi ritrarre l’addome e spingere verso alto. Mi-a-a-a-a-a…Mi-a-a-a-a-a. Prova!».
Il poveretto provò e riprovò, costretto tra l’entusiasmo e il pugno di quella donna :
«Mi-a-a-a-a-a…Mi-a-a-a-a-a…Scusami, Carmencita Romana…Ho una gran confusione in testa. E’ come se avessi perso l’orientamento!».
E l’altra:
«Capisco che non è possibile cambiare strada da un giorno all’altro. Devi accompagnare il diaframma nel suo movimento verso l’alto. Così spiegano i belcantisti. Garcia diceva di fare rientrare la fontanella dello stomaco e spingere in alto. Tu stai facendo l’opposto! E dovrei dirti altre cose».
Rufo annuì con la testa, come se avesse voluto dire:
«Avanti, leggimi il verdetto».
Beh. Allora. I vocalizzi si basano sulla ‘i’ e sulle ‘e’. Ecco. Sono queste le vocali che mettono avanti la voce. Le vocali chiacchierine, come diciamo noi soprani. Ecco. Poi metterai le altre vocali. Prova! La ‘u’. Lasciala perdere. Guai mai guai mai. O meglio. Con cautela, serve per affondare. E la bocca? Non devi spalancarla. Guai mai, guai mai. Tienila come in un sorriso. Il suono deve sbattere contro i denti. Insomma, non deve interessare il torace. Guai mai!Guai mai!
Insomma, se Mantovani avesse detto nero, la Barioni avrebbe controbattuto dicendo bianco, e viceversa. Questa fu una palese dimostrazione di quanto il canto e i cantanti siano in balia del relativismo e dell’approssimazione. E di loro stessi.
(Continua)