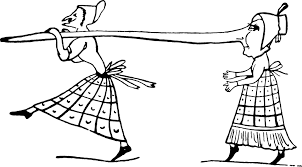Il passato della prozia stava in una scatola di cartone, tenuta insieme da alcune strisce di carta gommata. Dopo averla collocata ben visibile su di una mensola in cantina, nessuno le fece più caso, nessuno più la toccò. Si ricoprì di polvere.
Per anni Divina Pieranti fu dimenticata.
Qualche settimana prima degli avvenimenti che stiamo narrando, l’antenata fiorentina forse guidò lo sguardo di Rufo sulla scatola, suscitando in lui una nuova curiosità.
«Icché ci sarà qui dentro?», pensò Rufo.
La aprì e vide delle carte interessanti. Starnutendo per la polvere, riportò con sè l’urna di cartone in casa, tra le cose vive.
E il giovane tenore finalmente seppe che una Pieranti fu ammaliata, come lui, dall’arte del canto.
E che, in un teatro assai lontano, si conquistò onori e fama.
Una valigetta in similpelle era la nuova dimora che Rufo aveva dato ai cimeli della prozia e li mostrava a me e a Tullio, uno per volta, con divertita semplicità.
Sia i ritagli dei quotidiani che le pagine strappate dalle riviste, per prolungarne l’integrità, erano stati incollati da Lodovico Pieranti, il nonno di Rufo, con dovizia di gomma arabica su del cartoncino bristol ruvido, . Così s’erano s’erano assai incartapecoriti ed avevano preso odore di stantivo.
I brandelli di carta stampata uruguaiana, da El País, El Día, El Telégrafo, The Montevideo Times, La Razón, rappresentavano con tratti efficaci l’arte di Divina Pieranti.
I cronisti dipingevano una voce di bel timbro luminoso, nobile e dolce, ben modulata, eppure in grado di diffondersi nella sala del teatro Solís di Montevideo come un torrente in piena. Certamente era un soprano lirico spinto.
Descrivevano anche la bella figura, l’attrice affascinante, padrona del gioco scenico.
Insomma, Divina Pieranti pareva che fosse un’artista veramente coi fiocchi.
I primi giornali risalivano al 1919, allorché Divina Pieranti aveva sostituito la celebre ‘divina’ Claudia Luzzio in una Tosca con il celebrato Beniamino Valmigli. La ‘divina’ Claudia, dopo la prova generale, si prese un bel raffreddore, rimanendo afona per la prima. Fino a quella occasione, la prozia di Rufo aveva fatto solo le parti, come dicono alcuni in teatro, cioè la comprimaria. Anzi, il maestro Tullio Delli Angeli le aveva assegnato il ruolo del pastore, odiando le voci sempre stonate dei bambini.
Ma anche le ‘divine’ per fortuna si ammalano.
Suffumigi d’eucalipto, fumenti con bicarbonato e camomilla, bagni caldi, decotti d’erisimo e gargarismi d’acqua e aceto, non aiutarono la Luzzio a ritrovare la voce.
«Mors tua, vita mea», dissi.
«Ahaha, sì una vera botta di culo», chiosò Rufo ridendo. «Un’opportunità che può cambiare il corso dell’esistenza. Se tutto va per il meglio, ovviamente…»
E in quella mite primavera d’Ottobre sul Rio de la Plata il vento del destino parve spirare dalla parte giusta, gonfiando le vele di Divina Pieranti.
Il pubblico del Teatro Solís, così raccontavano i cronisti della serata, tributò un grande omaggio di successo ed onori non solo alla Pieranti ma anche al grande tenore Beniamino Valmigli, quella sera debuttante a Montevideo.
In una lettera della mattina successiva alla prima, il soprano descriveva al fratello com’era andata quella serata fortunata e, soprattutto, quanto i critici non poterono vedere. Dietro al sipario si ebbe un grande spettacolo senza canto, parallelo a quello della Tosca.
Il celebre tenore durante le prove aveva già messo in conto che dovesse fare il bis dopo ‘E lucevan le stelle’, al terzo atto dell’opera. D’altra parte questa romanza costituiva il suo cavallo di battaglia che infarciva di splendide mezzevoci, singhiozzi e svenevoli sospiri. La Pieranti però, dopo ‘Vissi d’arte’, al secondo atto, fu tanto acclamata che toccò le toccò di dover bissare per prima.
Lasciamo ora posto al racconto di Divina Pieranti.
Cantai Vissi d’arte come un bere un ovo.
E con gran garbo.
E stavolta non saresti stato proprio a riguardarmi le bucce.
Tu sai ch’io dico solo il vero. Pane al pane…chianti al chianti.
S’ebbero cinque minuti di applausi, non s’andava più avanti. Feci un cenno a Tullio Delli Angeli, che mi accompagnò da dio, e replicai. Alla fine della replica gli erano tutti più scalmanati di pria.
Calò il sipario. Nei camerini sentii che il Valmigli sbraitava con gran clamore. “Non faccio il terzo atto, chiamate un corista qualsiasi, oppure che Spoletta faccia il terzo atto al posto mia con quella fortunata sconosciuta”, egli diceva, anzi urlava. “Una cantantucola che conta meno il due di coppe quando la briscola è denari” aveva osato metterlo in ombra! Avevo ridicolizzato un celebre tenore! Guai mai!
Feci un gran malestro a scapito suo!
Icché si doveva anticipar l’atto o non dovea replicar la romanza per i suoi begl’occhi?
E Delli Angeli insieme all’impresario Bonetti, arrivati di corsa, gli fecero delle moine invano:
«Beniamino, non far così! Stasera stai cancellando il ricordo di Caruso».
Arrivò pure la Luzzio, ancora afona. Per riconoscenza ella m’avea fatto dono di un bel portagioie. Che donna squisita!
E si prese la briga di dar man forte ai due per convincerlo.
«Al posto della mia collega avrei dato anch’io il bis», gli disse per difendere la povera sostituta e per fargli capire di non rompere tanto le scatole, qualora si fosse risanata per cantare alla seconda recita.
Niente. Non servì a nulla.
Anzi, quel buzzone s’incapricciò di più. Sembrava che ci volesse della bella e della buona per far tornare il Valmigli in scena.
Per rabbonirlo, Bonetti gli promise il dieci per cento in più del compenso.
No, no, no e ancora no. Non esco!
Passavano i minuti. L’orchestra attendeva ammassata nella buca. Il publico rumoreggiava.
Pensai ch’io sola avrei potuto farlo rinsavire.
Mi infilai la mantella di scena, presi un mazzo di rose che m’avean regalato, escii dal camerino e bussai alla porta del tenore.
Entrai a testa bassa. Una ciuca con un viso umile e pentito:
«Può una piccola donna porgere le proprie scuse al grande artista?». E gli porsi i fiori.
Così blandito, quella testa di fava subitamente cadde nella mia trappola !
Valmigli cantò ‘E lucevan le stelle’ la prima volta bene, anzi benissimo. Da Valmigli, insomma.
Concesse il bis…Non puoi immaginare di quante smancerie e sbracature l’avesse infarcito.
Tante esche per attirare le trote. E il pubblico abboccò.
Gl’è punto bravo Valmigli, ma per due applausi in più porterebbe via il fumo alle candele.
Sicché sortii in scena io…La Pieranti però volea la sua rivincita. E tenni la ‘lama’ fino a che c’avevo fiato nei polmoni. Il ‘do’ mi venne talmente bello, grande, sicuro, ch’oscurai il Grande Tenore. Le gote gli presero il colore dei lamponi maturi.
Finito ‘O dolci mani’ ci fu un lungo applauso e lui mi ordinò, sottovoce, cupo:
«Attenzione a quello che fa! Niente code nel duetto!»
Tu m’hai sempre detto:
«Che chiorba dura tu t’hai!»
Te tu c’hai ragione.
Caro Lodovico decisi di fare una zingarata a dispetto del Sublime Artista. Son nessuno, ma a me nessuno comanda. Tanto meno quello zotico d’un babbaleo quale Valmigli.
A dispetto gli feci corone lunghe e dovette combattere con i miei fiati. Impresa difficile, come sai bene.
BimBumBam. Cavaradossi venne fucilato.
Valmigli finalmente a terra. Il palcoscenico era solo mio.
Gesticolai, mi disperai, tramenai da ossessa.
E poi dalla cima del Castel Sant’Angelo un ‘O Scarpia avanti a Dio’, lungo, anzi lunghissimo, tanto che il pubblico principiò ad applaudirmi coprendo l’orchestra. Urlarono tutti. Bonetti urlava a sua volta con le mani a mo’ di megafono. Anche Delli Angeli si spellava le mani dalla buca!
Non puoi immaginare il Valmigli e la solfa che mi fece allorché si chiuse il sipario! Sembrava una petonciana, tant’era scuro in volto. C’avea pure la gora che gli puzzava da sotto le ascelle della camicia.
«Per fortuna che lei è una donna e che io sono un gentiluomo…», mi si rivolse con le mani sui fianchi, come un’orcio per l’olio.
E urlò a Bonetti:
«In questo teatro di merda m’avete umiliato. Non canterò mai più qui. Mai più, mai più…Andrò all’Urquiza! L’anno prossimo c’andrò anche per metà del compenso!»
Nella sala il pubblico faceva una gran baraonda.
Scarpia escì da solo come terzultimo ed ebbe belle acclamazioni.
A Cavaradossi, penultimo, fu tributato un trionfo di applausi e di bravo.
Questi ritornò al di qua del sipario, io quindi mi avviai per incassare il mio successo, ma Valmigli mi trattenne prendendomi per il costume.
«No, guardi, lei non escirà da sola»
«Icché sta scherzando?» gli domandai.
«Non sto assolutamente scherzando, usciremo tutti e due insieme, tenendoci per mano»
«Neanche per sogno, l’opera s’intitola o non s’intitola Tosca? Uscirò da ultima e da sola!»
Allora Valmigli m’avvinghiò la mano. Gl’aveva perso il senno.
E allora, io levai il vino dai fiaschi: davanti a tutti, mollai al Valmigli un bel calcio negli stinchi.
«O bischero se te tu non ti levi da costì, il prossimo te lo fo sui coglioni che t’udran fin i santi in Orsanmichele»
Il Valmigli mollò la presa ed iouscii ritta come un fuso per prendermi un trionfo che mai scorderò per il resto della mi’ vita.
Io e Tullio eravamo piegati in due per le risate.
«Non fine ma efficace» dissi io.
«Hihihi, la mattina successiva l’impresario Bonetti sarà andato in chiesa per chiedere la grazia che la Luzzio si rimettesse in fretta…Non voglio immaginare le scintille tra la Pieranti e Valmigli durante una seconda recita», considerò Tullio.
Rufo prese fuori dalla scatola altre locandine. E così apprendemmo che l’indomita prozia di Rufo cantò nuovamente al Solís la Tosca con Miguel Fleitas, l’ Aida con Aureliano Perticher, e ancora altre opere come l’Otello al Colòn di Buenos Aires Nicola Lusati e, in giro per l’America australe, la Manon Lescaut, La forza del destino, Il Guarany. L’ultima locandina era La cena delle beffe con John O’Pellyran a Montevideo. Portava la data del 1926.
Rufo rivelò il contenuto di un fagottino in velluto rosso. Era monile da teatro senza valore, un diadema con tante gemme.
«L’ho lavato con il detersivo. Guardate come luccicano questi fondi di bottiglia!»
Forse il diadema della serata più preziosa di Divina Pieranti?
E poi trovammo altre lettere dirette al nonno di Rufo, scritte con una calligrafia di una volta, fitta, leggermente inclinata, affusolata nei ”l„, nelle “g„ e in tutte le maiuscole. Principiavano con “Mio adorato Lodovico…”, e nel fondo la data.
L’ultima lettera recava 30 settembre 1926, scritta dopo la prima dell’opera di Giordano.
E Rufo:
«Dopo questa data non vi sono più lettere e la vita della prozia è un mistero. So che mio nonno stette molto male e rimase lontano da Firenze per tanto tempo…forse persero i contatti. O tante altre cose. Forse che La cena delle beffe sia stata la sua ultima opera?»
«Andare in ricerca di Divina Pieranti potrebbe, allora, essere il pretesto per fare un bella vacanza! Non pensi?», risposi guardando le fotografie della prozia poste sul pianoforte.