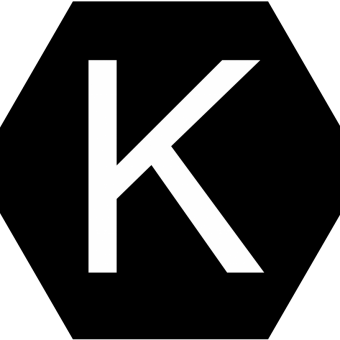Nel 1971 frequentavo la seconda classe del Liceo Scientifico.
In una tiepida mattina all’inizio di ottobre, tutte le finestre erano ancora spalancate, prevedevamo ore di baldoria poiché le assegnazioni dei professori andavano per le lunghe. Si ebbero risate sguaiate per le reazioni, schiaffi e calci, della Rosina Strocchi contro le assidue vessazioni di alcuni compagni. La gazzarra fu improvvisamente interrotta da una nuova insegnante che entrò con passo veloce. Si sedette alla cattedra mollando con un tonfo libri, registro e borsa.
«Buongiorno. Fate silenzio, per favore. Mi chiamo Lilia Armenghi. Sono la vostra professoressa di lettere», disse gravemente.
Seguì un silenzio immediato come dopo un fulmine a cielo sereno. Eravamo increduli: la professoressa ricordava Sylvie Vartan, la cantante yé-yé, oppure avrebbe potuto essere una valletta del Rischiatutto con Mike Bongiorno, al posto di Sabina Ciuffini. Lilia Armenghi indossava una minigonna e un piccolo gilet scamosciato, ricamato con fiori multicolori, sopra ad una camicetta bianca dal colletto a punte lunghe arrotondate, sbottonata fino all’attaccatura del seno. I lunghi capelli biondi, acconciati con una frangia, scalati, le incorniciavano il volto, gli occhi erano allungati da una sottile linea di china nera. E portava tacchi alti.
Sovvertiva decisamente gli usuali preconcetti sulle insegnanti liceali.
L’Armenghi, in contrasto, ben presto si rivelò un’insegnante scrupolosa, rigorosa, esigente, che infondeva grande passione perfino nelle letture de I Promessi Sposi e nelle lezioni di latino, assai più delle colleghe beghine.
E al terzo anno di liceo, la professoressa ci apparì un po’ cambiata, più ricercata nel vestire, più elegante nei gesti, con modi sofisticati ma asciutti. Prese anche a scrutare l’interlocutore socchiudendo gli occhi mentre s’insinuava, lenta e decisa, entro l’immateriale spazio prossemico dei suoi interlocutori. Il tracagnotto professor di filosofia Caterino Xibilia una volta ironizzò su questo: «L’Armenghi guarda in quel modo perché è miope, ma evita gli occhiali…teme che nascondano la sua bellezza… Però, quando si avvicina e fissa in quel modo, mi chiedo: mi butto o non mi butto? Ahaha!».
Noi allievi venivamo spesso disorientati dal susseguirsi di intellettuali considerazioni, talvolta mordaci, a inaspettate parole materne. Insomma, ora Lilia Armenghi era diventata una donna giovane, bella e affascinante. Ora ci appariva perfetta.
E aveva solo poco più di dieci anni rispetto a noi.
La professoressa iniziò il nuovo programma di letteratura leggendo le poche righe del Placito capuano dal Pazzaglia, l’antologia di letteratura italiana dalla copertina gialla come tuorlo d’ uovo.
Scandì le parole con voce altisonante:
«Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contiene trenta anni le possette parte sancti Benedicti».
Le lezioni si evolsero, diventando assai più elaborate rispetto a quelle dell’anno precedente. E capimmo che le ore trascorse con l’Armenghi erano speciali, assai diverse da quelle delle altre classi.
La bionda professoressa dischiuse una finestra sul mondo della linguistica, per cui le parole non furono più studiate solamente secondo le trite regole grammaticali, dell’analisi logica e del periodo: fummo i primi liceali bolognesi a ragionare sui concetti di significante, significato e referente, conoscemmo la differenza tra sincronia e diacronia. L’Armenghi ci introdusse anche ai fondamenti della semiotica, disciplina che a quel tempo veniva insegnata solamente all’Università di Bologna da Umberto Eco al DAMS. E ci entusiasmò tanto perché la semiotica sembrava poter indagare ogni aspetto del mondo, una religione senza dio. Tutta la classe divorò Diario minimo di Eco e Silvio Nocenti, particolarmente entusiasmato, prese in prestito dalla biblioteca comunale perfino La struttura assente, faticosa lettura di lì a poco abbandonata.
Il nostro orizzonte di adolescenti si ampliò in breve tempo e iniziammo così a riflettere su cose da grandi.
Molte lezioni ardevano di passione, specialmente quelle dedicate alle letture dantesche perché manifestavano poetica ispirazione. Quella dedicata al Decimo Canto dell’Inferno ebbe toni spesso accesi, intensi, temperati da una sottile regia studiata con meticolosa cura. Gli interessi germogliano e mettono radici più profonde se trovano terreno concimato dalla fascinazione.
E la professoressa si levò dalla cattedra, prese l’Inferno con il commento di Sapegno da un banco e incominciò a leggere passeggiando per la classe tenendo il testo piegato a metà. Quel libro usato, malconcio, almeno al terzo anno scolastico di vita, dopo che fu tenuto in mano, piegato, sgualcito, stropicciato dall’Armenghi e, soprattutto, sfogliato dalle dita leggermente inumidite sulle sue lucide labbra, acquisì il valore di una reliquia.
Le terzine del Canto X pervasero la classe:
«O Tosco che per la città del foco
vivo ten vai così parlando onesto,
piacciati di restare in questo loco».
Lesse con lentezza, talora scandendo, talora sussurrando, e con ampi gesti.
Il commento, le riflessioni si soffermarono sulle complesse vicende di Farinata degli Uberti e Cavalcante de’ Cavalcanti, epicurei dannati, sostarono sui suoni, sulle melodie, sulle dissonanze delle sillabe, sull’assenza di casualità nella scelta delle parole e sulle visioni evocate dai versi.
L’attenzione tributata alla lezione costituì per alcuni anche una facilitazione per ammirare senza magheggi la seducente bellezza della professoressa e, probabilmente, nella testa di Tommaso Gozzi, poco propenso alle suggestioni e al pathos danteschi, le parole a commento dei versi del Poeta si mischiarono a certe scene dei film con Edwige Fenech.
Seduto in un banco dell’ultima fila, Gozzi era un tipo massiccio con capelli rossi ed efelidi dalla vista lunga: fingendo di cercare i ray-ban a specchio nel proprio giubbotto di pelle, si alzò in realtà per raccogliere un lungo capello biondo perso dall’Armenghi su di un loden blu. Gozzi esibì ammiccando, con sorriso fino alle orecchie, il prezioso trofeo. E seguirono gomitate, cenni, occhiate, risatine senza che la professoressa s’accorgesse di nulla. Il suono della campanella fece svanire la lezione sugli epicurei nel nulla. Gozzi incartò il trofeo tricologico con un foglio di quaderno, e in pochi minuti lo vendette a Dario Franchi, giocatore di basket appena discreto quanto ottimo playboy millantatore, per ben mille lire.
Le preziose lezioni di Lilia Armenghi, come bottiglie abbandonate in mare, sarebbero state ritrovate da qualche allievo, prima o poi, durante la vita. Non intendeva convertire alla lettura, la professoressa era semmai una sorta d’astuta mezzana che combinava incontri con i grandi scrittori. Sperava di fare nascere l’amore per la lettura o che, almeno, qualche verso armonioso, qualche parola ispirata, raggiungessero anche le menti dei più riottosi e distratti.
Fece una raccomandazione:
«Leggete ora perché, quando sarete grandi, non ne avrete più tempo. Solo da giovani ci si può trastullare in cose inutili come la lettura dei romanzi e dei poeti!».
E con l’Armenghi ammirammo così gli inutili gioielli di Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Machiavelli, Guicciardini, Tasso…
(Continua)