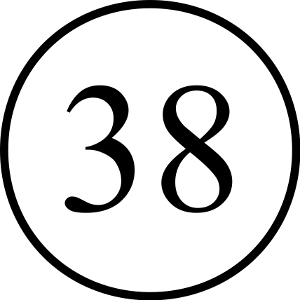Alla fine della terza classe, trapelò dalla sala insegnanti la funesta indiscrezione che, in estate, la professoressa si sarebbe sposata. Fu considerato uno sgarbo imperdonabile da alcuni allievi maschi:
«Cazzo, ma come si permette?».
«Chi si crede di essere quella?».
«Ma vaaaffancùuulo!».
Il tombeur de femmes Franchi era incredulo. Se questa notizia fosse stata vera, proprio lui, che faceva goffe moine di corteggiamento alla professoressa, sarebbe stato il più danneggiato. Trovò, allora, il coraggio di chiedere con un sorrisetto:
«Prof, è vero che si sposa?».
«Sì», gelò laconicamente l’inopportuno con marcata indifferenza, senza nemmeno alzare la testa dal registro di classe mentre scriveva i cognomi degli assenti.
Sparì il sorriso all’allievo. E Franchi declassò a sua volta la Prof a insegnante di lettere di seconda scelta. Come nella celebre favola di Esopo, trovò così anche l’impudenza di dire:
«Ma non è nemmeno tutta ‘sta bellezza…che voli basso quella».
Le ragazze invece gioirono:
«Grande, Prof!»,
«Complimenti Prof!». Speravano che, tolta di mezzo l’Armenghi, qualcuno dei maschi si sarebbe finalmente accorto di loro.
Il quarto anno iniziò con un gran bailamme di professori. Dell’anno precedente erano rimaste solo l’Armenghi e l’insegnante di matematica. Alla fine di ottobre, dopo dei giorni di assenza, la professoressa ci comunicò che sarebbe stata sostituita da una supplente per il resto dell’anno scolastico. Capimmo che era in stato interessante.
«Prof, ritornerà in quinta?».
«Vedremo».
Avevamo ascoltato una sua lezione per l’ultima volta perché l’Armenghi, purtroppo, non ci condusse nemmeno alla Maturità. Nella graduatoria di istituto fu superata da una professoressa di Formia che aveva chiesto il trasferimento, affascinata da Bologna. Intese cambiare vita…a spese nostre!
Poverina, la nuova insegnante di lettere non poteva certamente reggere il confronto con l’Armenghi da alcun punto di vista. Così esprimemmo il desiderio di avere il professore di filosofia Caterino Xibilia quale commissario interno all’esame di Stato. E questi ebbe tanta personalità e forza da esautorare la nuova professoressa imponendo il programma che molti di noi allievi, sotto e oltre gli influssi dell’Armenghi, intendevamo portare all’esame. Per una volta ci illudemmo che si poteva mettere l’immaginazione al potere. Anziché la letteratura italiana e riuscimmo a spuntare una bellissima rassegna di grandi scrittori europei moderni, Oscar Wilde, Marcel Proust, Robert Musil, Gabriele D’Annunzio, James Joyce, fino al Nouveau Roman di Alain Robbe-Grillet. E tutta la classe superò brillantemente la maturità.
Iscritti all’università, io e Antonio Russo andammo più volte a trovare la professoressa Armenghi nella sua casa in pieno centro, di fronte all’Arcivescovado.
Ci accoglieva con calore, manifestando un’inaspettata complicità salottiera senza alcun alone professorale, alla pari.
La cura del figlio le rendeva difficoltoso trovare il tempo per la preparazione delle lezioni e, pur non avendo nemmeno un anno, il piccolo metteva il bastone tra le ruote durante la correzione dei compiti in classe. Aveva capito che la mamma si dedicava ad altri e, per questo, buttava per terra, stracciava, i fogli protocollo con temi e versioni da correggere. Voleva la madre tutta per sé, non disposto a condividerne il fascino con altri?
E l’arte di esser mamma toglieva tempo al suo amore per i bei libri. Subiva le esortazioni sulla lettura che fece in classe qualche anno prima.
Un pomeriggio il bambino aveva la febbre, la nostra visita fu dunque breve. L’Armenghi ci raccontò che aveva deciso di prendere due piccioni con una fava leggendo a voce alta la Storia della follia di Michel Foucault per calmare la smania del figlio e andare avanti con il libro!
Durante l’ultimo anno di liceo, Antonio Russo aveva evidenziato strani comportamenti. Alternava periodi in cui era taciturno, scontroso e dormiva sul banco a episodi di incontrollata euforia, spesso fuori luogo rispetto al contesto del momento. Queste stranezze alla fine si mimetizzarono con la frenesia della Maturità e nessuno più diede importanza a Russo. Soffriva di disturbo bipolare.
Al primo anno di Università, si iscrisse a Storia e Filosofia, i comportamenti di Russo diventarono ancor più inconsueti, si aggravarono. Occupò la casa della nonna scomparsa stipandola di libri e lì si ritirava in totale solitudine per leggere di filosofia, storia, poesia e romanzi. Passava intere settimane senza vedere anima viva, totalmente immerso nella lettura, credo che sia stato uno dei pochi ad aver letto Il capitale di Marx per intero, quindi usciva e mi telefonava per vederci.
Quando l’umore era buono parlava delle sue letture solitarie oppure leggeva, su di giri, da grossi quaderni le frasi copiate dai libri. Altrimenti passeggiava accanto a me senza parlare, preda di un’evidente inquietudine.
In un giorno di depressione mi disse con apparente consapevolezza:
«Sto male…ero un ragazzo semplice destinato a fare il calciatore, ad avere delle ragazze, una moto. E invece…l’Armenghi mi ha fatto conoscere l’Ariosto!».
E anche il senno del povero Antonio Russo se ne volò sulla Luna senza che più uno psichiatra, al posto di Astolfo, glielo riportasse indietro.
Tra la mia abitazione e quella dell’Armenghi corrono meno di ottocento metri, entrambi viviamo in centro. Eppure per quasi quattro decenni non ci siamo mai incontrati per strada.
In questi anni, prima del sonno, il mio pensiero ha rivissuto più volte, con dolce nostalgia, l’aetas aurea del liceo. Avevo tanti progetti, tante speranze, tanto futuro perché non pensavo alla finitudine delle cose. Forse la mia vita ha avuto il culmine proprio in quegli anni giovanili.
Per diverse volte mi sono detto:
«Che fine avrà fatto l’Armenghi? Sarà cambiata? L’avrò incontrata e non l’ho riconosciuta…oppure sarà capitato il viceversa!».
Nel 2013 ricevetti una telefonata in ufficio:
«Pronto…sei Marco?».
«Sì…ma tu chi sei?»
«Sono Sabrina…Sabrina Rondelli».
Riconobbi immediatamente la comare di tante telefonate pettegole alla domenica sera.
Mi emozionai e le manifestai grande gioia.
Il motivo della telefonata era quello che aveva intenzione di organizzare una cena di classe, una rimpatriata.
«Tu verresti? Verso la metà di giugno…vorrei fare anche un gruppo segreto su Facebook per tenerci in contatto».
Accettai con entusiasmo, e chiesi con inquietudine:
«Devi però dirmi subito una cosa…ci siamo ancora tutti?».
«Sì, sì, ci siamo tutti, non preoccuparti. Sai? Hanno accettato anche Xibilia e l’Armenghi. Non ho cercato altri professori. Anzi ho già incontrato l’Armenghi. È ancora bella com’era quando eravamo a scuola, sempre affascinante ed elegante!».
Passò qualche giorno e Sabrina mi invitò ad una cena in casa sua prima della rimpatriata generale al ristorante.
«Saremo in pochi, i più intimi…Ci saranno la Monica e la Lilia».
Mi avviai all’appuntamento vestito di tutto punto e, come si usa, portai un omaggio floreale per ogni signora.
Arrivai all’appuntamento in anticipo, con agitazione. Parcheggiai e mi avviai per il vialetto che conduceva all’entrata.
Vidi la professoressa confusa nella penombra del crepuscolo, accanto alla porta, e mi misi a correre verso di lei.
«Eeeh…Marco… Marco…».
Ci stringemmo in un lungo abbraccio.
«Lilia…ancora ricordo la lezione su Farinata degli Uberti!», dissi in balia della commozione.
Non era pressoché mutata, come un dipinto in cui la patina del tempo offusca i colori senza modificare le pennellate.
E però, quanto alle ingiurie degli anni, anche Sabrina e Monica se la passavano abbastanza bene.
La serata fu molto gradevole e vinsi l’imbarazzo del tu alla non più irragiungibile professoressa di lettere. Il tempo ci aveva pareggiato con perfida democrazia. E la accompagnai a casa in automobile.
La grande cena di classe fu assai piacevole, all’insegna di una festosa cordialità. Il professore di filosofia Caterino Xibilia fece, come sempre, il mattatore, seppur mitigato dalla professoressa di lettere. Così facemmo notte fonda.
Fu però l’unica riunione della classe intera, d’altra parte trentotto anni trascorsi senza il bisogno di rivederci hanno un chiaro significato: l’assenza di desiderio è mancanza d’amore. Tutto è ritornato come prima.
Per quanto mi riguarda, quell’incontro di tarda primavera mi ha fatto ritrovare Lilia nelle vesti di preziosa amica.
Le persone importanti bisogna tenersele strette.
(Fine)