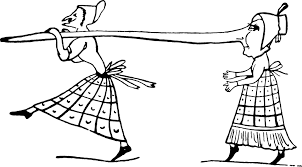Cantai delle scale discendenti, giù giù, fino a che m’era possibile intonare le note. Avevo una discreta facilità nel registro medio e grave.
Mantovani aggrottò le sopracciglia, si grattò vicino al bordo del parrucchino. Sembrava aver acquisito l’ultimo elemento necessario per esprimere il suo giudizio.
Si riempì d’aria, scosse la testa risolutamente. Doveva affrontare un discorso difficile.
«In sincerità, non me la sento di pestar ancora acqua nel mortaio. Abbiamo fatto diverse lezioni ma i miglioramenti sono stati pochi. Io vorrei che tu provasti a cantare come barittono».
Suonò un mi e un fa al pianoforte:
«Queste note, per te, dovranno essere degli acuti, non note di passaggio. Il suono sarà giusto, più gradevole, anticipando il passaggio di registro come fanno i barittoni smetterai di strozzarti. Tu sei un barittono, insomma».
E proseguì con la sua ‘pillolina’:
«Per il tenore, invece, il fa è il principio di una scalinata che porta ai piani alti fino al solaio. Un tenore non può faticare su di un fa. Tu ora su queste note fai un trasloco! Sta attento: Mi-aaaaa… Mi-aaaaa…Mi-aaaaa… Senti com’è tutto semplice per me? È dolce come se cantassi una frase di romanza. Ora prova tu, canta, canta mo’ da tenore».
Ripetei il vocalizzo.
«Avverti qualche differenza tra me e te?»
Una domanda retorica. C’era tanta differenza! Il vocalizzo eseguito da me era indubbiamente faticoso, con suono aperto, non ben controllato.
Era un trasloco, appunto.
«Queste note sono così spapellate…perchè te non sei micca un tenore».
E il maestro di canto rimpolpò ulteriormente le sue argomentazioni per straconvincermi:
«Su queste note un vero tenore deve cantare romanze su romanze con facilità. Il barittono qui, tra il fa e il sol, invece, è quasi arrivato al capolinea, ci fa solo degli effetti. Prende gli applausi e si cucca i soldi».
Suonò le ultime note di Celeste Aida:
«Questo per me è un acuto…un trono vicino al soooool, un trono vicino sooooooooooool» e smorzò il si bemolle, tenendolo fino a che diventò rubizzo.
«Oddioddio me…che capogiro!»
Sembrò stramazzare per terra. Fece un po’ il guitto. A Mantovani piaceva condire i propri gesti come se fosse su di un palcoscenico.
Si riprese e continuò:
«Se dovessi cantare sempre in questa zona sarebbe per me…come inghiottire della ghiaia senza berci dietro almeno un bicchier d’acqua! Rendo l’idea? Ahaha»
«È un metafora assai efficace», risi anch’io.
«Metafia? Che cos’è? Me lo spiega lei, signor letterato?», fece con sguardo furbetto, bonariamente sfottitorio.
«Una specie di paragone», risposi, nuovamente ridendo, tagliando corto.
E gli chiesi a mia volta:
«La mia voce non è per caso troppo chiara per essere un baritono? A me disturbano certi cantanti troppo corti per essere tenori e troppo chiari per essere baritoni!»
I Francesi designano in maniera curiosa, ma precisa ed efficace, queste voci che hanno caratteristiche di entrambe le corde vicine, cioè che non sono né carne né pesce rispetto al colore vocale e all’estensione: usano il cognome del cantante ritenuto capostipite di quel tipo vocale o che ha dato ad esso un’adeguata notorietà.
I mezzosoprani dalla voce lunga, potente e squillante vengono così denominati ‘falcon’, in onore di Cornélie Falcon, creatrice dei più bei ruoli del Grand Opéra. I falcon potrebbero però essere anche dei soprani dalla voce bronzea nei centri, ideale per le parti verdiane.
Per i cugini d’Oltralpe ci sono anche i soprani ‘dugazon’. Nel diciottesimo secolo, Madame Dugazon fu il nome d’arte con cui si fregiò un’artista tuttofare, un po’ cantante un po’ ballerina e un po’ attrice, presunta antesignana delle soubrette corte, dotate di un registro centrale vagamente mezzosopranile e con scarsa polpa vocale.
Jean-Blaise Martin fu, invece, un baritono che cantò a cavallo del ‘700 del ‘800. La Francia è terra di baritoni ‘martin’ che si distinguono per un timbro quasi tenorile e, se dotati di buona tecnica e da buone stelle, per la facilità nell’emissione degli acuti.
Io sarei stato forse un baritono ‘martin’?
Orrore!
Mantovani rispose prontamente ai miei dubbi sull’identità vocale:
«La voce funziona come una coperta che non riesce a coprire le spalle e i piedi al contempo. Se la tiri in alto si scoprono i piedi, se la tiri verso il basso si scoprono le spalle. Dai e dai, tira e tira la coperta verso l’alto, la tua voce si è schiarita. Hai voluto fare il tenore perché ti piace, per divertimento. Ma, volendo studiare seriamente, devi sapere che la tua voce appartiene a un’altra razza. Se lasceremo perdere gli acuti, se lasceremo fare alla natura, pian piano la coperta si sposterà da sola e uscirà il colore giusto da barittono, verrà fuori la tua vera voce».
Chiuse il pianoforte.
Questo gesto parve significare:
«Basta coi sogni!»
Un sordo tonfo dello sportello fu il commiato alle mie aspettative tenorili.
«Allora, per oggi abbiamo finito. Signor letterato, ora sta a te. Sammi dire quello che intendi fare, se vuoi continuare a studiare da barittono».
Stavano davanti a me due strade: o salutare le lezioni di canto, ostinandomi a fare il tenore, oppure indossare i ‘vili panni’ del baritono.
Il saggio maestro di canto, a mano a mano che parlava, sempre più mi convinceva. Avevo fiducia di quell’uomo.
La decisione mi parve scontata: non potevo che incamminarmi per la nuova strada.
Ritornai casa non pensando più al canto. Ed ero perfino allegro convinto di aver fatto una buona scelta.
Avendo una fame da lupo, mi misi a tavola di gran furia.
E driiiiinnn!
Il telefono suono più che mai sincronizzato con la mia cena.
Era Tullio. Per la mezz’ora di Radio Serva.
«Novitàaa?», mi chiese secondo il rodato copione.
Di novità ne avevo, quella sera. Eccome che ne avevo!
Dimenticando l’uggia famelica, raccontai per filo e per segno quanto era successo poco prima durante l’ora di canto con Mantovani.
Tullio ascoltò con grande interesse ma, al termine del racconto, mi fece girare le scatole con la sua insopportabile saccenteria:
«Certo! Ho sempre pensato che tu fossi baritono. E sei calante per questa ragione».
Usò un tono severo e cinico che, più eloquentemente delle parole dette, sembrava voler esprimere:
«Finalmente qualcuno te l’ha cantata per bene!»
Quella volta mi ferì più per il tono adoperato che per il significato delle sue parole.
L’avrei mandato a quel paese ma dovetti controllarmi per non mandare a monte una buona amicizia, seppur segnata da alcune insofferenze caratteriali, soprattutto da parte mia.
E gli risposi risentito:
«Perché hai lasciato passare tutti questi anni senza dirmi ciò che pensavi? Dovevi proprio attendere l’occasione delle lezioni con Mantovani?».
Mi infastidisce chi non trova mai i toni giusti per raccontare la verità – la cosa più difficile da tradurre con giuste parole. Mi infastidiscono, del pari, certi ‘grilli parlanti’ che, al compimento dei fatti, confessano d’aver capito, fin dall’inizio, tutto quel c’era da capire. Quante scarpate tirerei a questi grilli! Inutili Cassandre del giorno dopo!
Tullio, invero, le sue ‘cosine’ sulla mia voce le aveva grossolanamente manifestate dacché mi ascoltò per la prima volta. Le sue ragioni – la verità, insomma – però, infastidendomi, essendo malamente espresse, rimbalzavano su di me.
Era una questione di scarsa sensibilità per la mia sensibilità.
Dopo la mia risposta seguì un istante di silenzio imbarazzato e, poi, Tullio fece orecchie da mercante fingendo falsa disinvoltura:
«Altre novitàaa?»
Non avevo certamente intenzione di continuare a fare Radio Serva, tanto meno di discorrere su me stesso. Liquidai in fretta Tullio, quella sera più che mai irritante.
Dopo la cena presi fuori dalla libreria il cofanetto de I Puritani e posi il primo disco dell’opera sul giradischi. Anziché cantare sugli acuti siderali, tenorilissimi, di A te o cara, cantai l’entrata di Riccardo Forth. Tanto bella quanto lagnosa.
E tanto baritonale.
Ha!, per sempre io ti perdei
Fior d’amore, o mía speranza
Ah! La Vita che m’avanza
Sara piena di dolor!
Quando errai per anni ed anni
In poter della ventura
Io sfidai sciagura e affanni
Nella speme del tuo amor
Mi pareva di passare da una generosa fetta di cassata siciliana, un piacere per il palato e per gli occhi, ad una mesta cucchiaiata di tiramisù dell’amico Celestino – fatto con i pavesini male imbevuti, conditi di una crema al mascarpone assolutamente insapore e inodore.
Dopo questa romanza, per provare il piacere di quando si addenta una bella porzione di pinza montanara ripiena di sapida mostarda bolognese, presi fuori i Pagliacci per cantare il Prologo, manifesto del verismo in musica:
E voi, piuttosto
che le nostre povere gabbane d’istrioni,
le nostr’anime considerate,
poiché siam uomini
di carne e d’ossa,
e che di quest’orfano mondo
al pari di voi spiriamo l’aere!
Il concetto vi dissi…
Or ascoltate com’egli è svolto.
Andiam. Incominciate!
E’ facile immaginare quanto meno faticassi cantando gli acuti del Prologo – il la bemolle di ‘al pari di voi’ e ancor meno con il sol di ‘andiam, incominciate’ – rispetto alle impervie scalate sul pentagramma tenorile di Arturo nei Puritani o di Arnoldo nel Guglielmo Tell.
Tutto appariva senz’altro più comodo.
Ma l’umbratile colore baritonale non c’era.
Telefonai a Rufo.
Con il passare delle settimane avevamo preso a vederci e a sentirci senza la mediazione di Tullio. Il Deus ex machina si trovò messo un poco in disparte. E questo parve un boccone duro da digerire per colui che ci aveva presentato. Ben presto nacque tra noi una divertente complicità.
« Mò cosa vuol che le dica scior Rufo, è così, insomma…Non invecchi mica sa?», esordii con un tormentone, il verso a Donna Fernanda.
«Non puoi immaginare cosa è successo a lezione con Mantovani!»
Pensavo di fare il botto, di stupire il mio interlocutore…e invece Rufo sapeva già tutto! Mantovani l’aveva chiamato subito dopo che ero uscito.
Che Rufo fosse stato l’oscuro artefice del mio passaggio da tenore a baritono?
Che avesse convinto Mantovani e questi avesse convinto me?
Gli sciorinai ugualmente il resoconto della giornata però con maggiori dettagli. E con i miei dubbi.
«Insomma, seguendo i consigli di Mantovani vedrai che andrà tutto per il verso giusto. Per ora sei ‘tenoritono’ ma diventerai baritono», mi fece Rufo con tono sicuro e rassicurante. E continuò in maniera leggera:
«Ma che bello! Potremo cantare insieme i tre duetti della Forza del destino!»
«Se è per questo, ci sono i due dei Vespri Siciliani» dissi io.
«E non vogliamo fare quello del Don Carlos, dell’Otello, della Lucia, della Gioconda? Mi sa che ci divertiremo più di prima! Non ci sono molti duetti per due tenori, », concluse Rufo.
L’amico tentava di rendermi più attraente la corda baritonale: si allontanavano da me le romanze più belle perché i musicisti sembravano aver riservato per i tenori la migliore ispirazione. Addio agli amorosi, agli eroi, ai cavalieri, ai poeti.
Ai baritoni rimanevano nobili azzimati, padri, amanti cornuti, qualche cattivo e i buffi. Una folla di personaggi meno affascinante per sognare.
Iniziò una nuova routine di studio. L’invito del maestro fu, innanzitutto, di non cantare più romanze tenorili. Mantovani avrebbe pure voluto, per un po’ di tempo, che mi fossi astenuto dal cantare le romanze baritonali fino a quando non fossi stato «pronto».
Ma facevo di testa mia.
Dovevo controllare se le cose cambiavano rispetto al passato.
Aveva ragione Mantovani. La voce si riappropriò della sua natura, come un torrente che, passata la piena per un temporale, riprende in poco tempo il proprio corso scavat.
Esercitandomi da baritono, non riuscii più a cantare come tenore. Steccavo tutti, ma proprio tutti, gli acuti di cui, fino a poco tempo prima, io solamente ero tanto orgoglioso!
Temendo che la mia nuova voce di baritono smarrisse i minuscoli progressi, Mantovani non accennava a che provassi cantare delle romanze intere. Solo qualche frase, e nemmeno troppo impegnativa.
In un certo pomeriggio, però, sentii la necessità di un cambiamento prima della fine di quel giorno stesso.
Dovevo imparare a fare questo benedetto passaggio di registro.
Dovevo arrotondare la voce perché risuonasse come sotto ad una cupola di una chiesa.
Dovevo abbottonare il suono per ottenere un timbro baritonale come una vecchia marsina di mezza stagione.
Dovevo tirare fuori una voce scura, a costo di rimanere afono, una volta per tutte.
Presi allora i dischi del Boris Godunov e cantai la scena dell’Incoronazione con il libretto sotto gli occhi, per leggere il russo traslitterato.
Skorbit dusha! È triste l’anima… Cantai e ricantai di tigna.
E un colore di voce scuro alla fine uscì. Avevo imparato ad aprire la gola come si comanda facendo risuonare la voce nel petto, la più grande cassa armonica che l’ uomo possiede.
Provai una, due, tre volte. Il suono usciva sempre uguale. Bello? Brutto? Che importava? Imitando un basso sembravo un baritono vero, non un inutile baritono ‘martin’.
Avevo trovato la strada? Mi pareva perfino riuscir a ‘girare’ il suono nella maniera giusta!
Avevo forse capito come fare il passaggio di registro?
E Rufo, a cui feci ascoltare i miei tentativi in anteprima, seduto al pianoforte, approvò con un entusiasmo… controllato. Rimaneva in attesa dell’approvazione di Mantovani:
«Mi sembra che il ‘giro’ sia giusto. La voce è senz’altro più scura».
Capii che ero migliorato, ma meglio non voleva dire bene.
Mantovani sembrò più stupito di Rufo per la metamorfosi:
«Non so micca… Oggi hai un’altra voce. Ma cos’hai fatto? Sei stato miracolato? Va molto meglio, è più nella linea»
Non gli narrai delle alchimie casalinghe come basso, sperimentate qualche giorno prima, né le avrei mai raccontate a nessun altro.
Un segreto di cui sarei stato l’unico depositario.