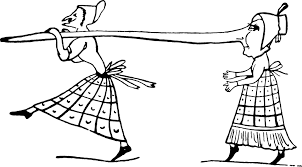Per merito di mio padre, sono stato un ascoltatore di musica lirica molto precoce. A dieci anni possedevo una discoteca di dodici opere che conoscevo a menadito: La traviata, Rigoletto, Aida, Otello, Il Trovatore, Nabucco, Norma, Carmen, Andrea Chenier, Cavalleria Rusticana, La boheme, La forza del destino.
Poi mio padre se ne andò. Per i successivi tre anni delle scuole medie ebbi allora un rigetto dell’opera ed ascoltai per lo più musica leggera, con un blando interesse per la musica sinfonica che si sviluppò durante gli anni del liceo. L’opera lirica, invece, riprese con calma il posto di privilegio da cui era stata spodestata.
Il mio gusto musicale era stato impostato da mio padre, sia per il repertorio che per gli interpreti; amavo l’opera italiana e i cantanti di vecchia scuola. Il repertorio ben presto si ampliò grazie alla mia istintiva curiosità ed anche alla buona paghetta settimanale di mia madre, che mi permetteva di acquistare i biglietti per il teatro, una bella quantità di nuovi dischi, libri e riviste musicali. E poi fu importantissima, in questo, la radio che in quegli anni trasmetteva ben tre opere alla settimana, insieme alla filodiffusione.
Per quanto riguarda gli interpreti vocali, pur avendo ben educato da bambino l’orecchio sulle voci di Aureliano Pertile, Beniamino Gigli, Renata Tebaldi, Maria Callas, Gina Cigna, Maria Caniglia, Mario del Monaco, sentii il bisogno di sapere cosa ne pensavano gli ‘altri’, quelli che ne sapevano più di me, cioè i critici musicali. In questo senso mi furono tanto utili ancora le trasmissioni radiofoniche, prima fra tutte – durante le mattina delle vacanze scolastiche – era Antologia operistica, in cui venivano presentati i brani d’opera talvolta con il commento dei cantanti lirici.
Seguivo fedelmente, ogni martedì sera, verso le venti, Il melodramma in discoteca di Giuseppe Pugliese che offriva un ascolto comparato, per ogni opera, delle migliori edizioni discografiche e, soprattutto, spiegandone il perché. Queste erano trasmissioni bellissime, dal taglio quasi scientifico, dei veri saggi radiofonici.
Circolavano per la radio anche l’autorevole Angelo Sguerzi, nostalgico testimone di epoche teatrali passate, e Giorgio Gualerzi, infallibile memoria del teatro in musica.
A me piaceva tanto, il sabato pomeriggio alle sedici e trenta, ascoltare anche Di tanti palpiti con l’originale presentazione di Franca Valeri.
E poi si concludeva la settimana, alle ore venti della domenica, con le rubriche di Franco Soprano dedicate alla musica lirica, quasi dei rotocalchi lirici che nel tempo ebbero titoli differenti: Il mondo dell’opera, Opera 77, Opera 78, Il pescatore di perle. Ascoltavo queste trasmissioni senza passione, forse perché Soprano mi appariva troppo affabile e cordiale. Le sue presentazioni o recensioni apparivano prudenti, dando un colpo al cerchio e un colpo alla botte.
Di ben altra pasta era il critico romano Rodolfo Celletti: le sue recensioni all’occorrenza erano delle cannonate rivolte contro direttori d’orchestra e cantanti. Scoprii la polemica, corrosiva, vivace penna di Celletti sulle pagine del mensile Discoteca Alta Fedeltà su cui recensiva i dischi delle opere italiane e francesi – le altre opere venivano presentate dagli ottimi Rubens Tedeschi e Giuseppe Pugliese.
Celletti si schierava contro quello che, a suo avviso, in quegli anni costituiva il declino dell’opera: il mal canto verista e il suo stile. Il critico romano sognava un canto dallo stile puro, stilizzato, interamente vissuto all’interno della musica, con il preciso rispetto dei segni espressivi dei musicisti, senza eccessi o volgarità, un canto filtrato dalla filologia sia nella esecuzione musicale che in quella interpretativa. Un canto allucinato, come diceva lui. E si schierava decisamente contro chi non perseguiva il ripristino dell’Aetas Aurea del Belcanto così come lui prefigurava.
Creò così un bel registro con i buoni e i cattivi; tra i cattivi c’erano dentro cantanti di gran nome che calcavano i più grandi palcoscenici, che incidevano per le più importanti case discografici.
Quale unica deroga a questa regola, ammetteva solamente l’enfasi espressiva di Magda Olivero perché amava follemente questa grande artista.
Il ritorno filologico alle antiche prassi esecutive, perdute con il verismo -prassi mediate dalla trattatisca sette-ottocentesca o da certe pagine dedicate al canto da grandi scrittori- fu dapprima intravvisto da Celletti principalmente nel canto delle voci femminili. Le sue cantanti erano Maria Callas, in quanto diede la stura a questo processo di rinnovamento, ovvero di ritorno all’antico, e poi Joan Sutherland, Leyla Gencer, Beverly Sills, Marilyn Horne, nonché Montserrat Caballé dei tempi migliori. E su troni a parte, solo per via dei repertori, collocava Renata Tebaldi insieme a Magda Olivero. Le voci maschili gli parevano più riottose ed approvava a quell’epoca pochi tenori in carriera: Carlo Bergonzi senza riserve e, nonostante l’algidità, Alfredo Kraus.
Queste idee, sempre felicemente esposte, piacquero assai ai noi giovani melomani. Celletti fu il maître-à-penser della nuova generazione di spettatori del teatro d’opera. E così diventammo tutti antiveristi e seguaci del Belcanto.
E massacravamo i cantanti al di fuori da questi canoni.
Al Festival della Valle d’Itria si materializzarono gli ideali estetici e vocali di Celletti in quanto ne fu direttore artistico per ben tredici anni.
All’inizio degli anni ’80 i tempi ormai erano maturi per la Rossini Renaissance con la nuova stirpe di cantanti rossiniani. E Celletti sembrò esserne profeta e mentore.
Raccolse le sue recensioni in un libro, Il teatro d’opera in disco, che divenne una specie di Bibbia. Per conoscere quello che dovevamo pensare noi, giovani melomani, andavamo a leggere questo libro e ci adeguavamo in conseguenza.
I miei giudizi spesso iniziavano con le parole «Come dice Celletti…»
A mio avviso, il miglior Celletti lo troviamo prima che prendesse vita compiutamente l’estetica cellettiana, cioè nelle sezioni da lui curate per un libro del 1964, Le grandi Voci.
Possiamo dire, fino a questo punto, che Celletti fece un’opera meritoria: crebbe una nuova generazione di ascoltatori impostandone il gusto in termini rigorosi. Eravamo i cellettini.
Però…
Ci sono stati due però.
Primo però. Se Celletti ogni tanto nelle sue recensioni ricordava che l’opera in disco è un mondo a parte rispetto a quello dell’opera in teatro -e ci mancherebbe altro!- viceversa i suoi giovani seguaci non sempre parevano ricordarsene, facendo d’ogni erba un fascio. Il canto in disco è artificiale; nell’esecuzione in studio si possono fare dei begli effetti che dal vivo, in teatro, sono difficoltosi da realizzare. In disco si può creare un qualcosa che nella realtà non è mai esistito così come l’ascoltiamo nel suo risultato finale. Le recensioni di Celletti crebbero uno stuolo di piccoli cellettini massimalisti che, in teatro, pretendevano sempre e comunque la perfezione dello studio di registrazione, giudicando in conseguenza.
Secondo però. Le recensioni di Celletti sempre entravano a capofitto nel merito della tecnica del canto. Parlava non solo a cellettini profani -non a cantanti- di suono in maschera, di suono affondato, di suono avanti, di suono indietro, dei vari tipi respirazione, di appoggio, di suoni di testa, di suoni di petto e così via. Questi concetti Celletti li apprese con la frequentazione di Giacomo Lauri Volpi, cantante per il quale aveva una sconfinata ammirazione sia dal punto di vista tecnico-vocale che dal punto di vista interpretativo.
Il risultato fu che noi cellettini iniziammo a pontificare sulla tecnica vocale. Già i cantanti spesso capiscono poco di tecnica vocale, figuriamoci quello che potevamo capire noi, cellettini, dalla mera lettura di recensioni di opere registrate in studio! Appare ovvio che spesso si affermassero delle belle minchiate in allegria e senza vergogna…tanto ce l’aveva detto Celletti.
Per quanto mi riguarda, nel 1980, pensai di prendere delle lezioni di canto e appresi quanto fosse difficile incamminarsi per la strada maestra. Dopo sei mesi piantai tutto perché il canto non era cosa per me. I casi della vita mi diedero però l’opportunità di conoscere diversi maestri di canto, alcuni illustrissimi, e mi resi conto che nel canto ci sono diverse strade percorribili, ognuna delle quali conduce in luoghi differenti ovvero che esistono molteplici tecniche di canto in grado di produrre vari, ed assai differenti, tipi di suono. Quanto predicava Celletti sulla tecnica di canto -spesso descriveva nei suoi articoli la sua tecnica di canto, condivisa e attuata da alcuni insegnanti- produceva cantanti dalle voci che proprio non gradivo: magari bravi o nel fare le agilità, o nel legato oppure nell’eseguire i segni di espressione dell’autore ma, per contro, avevano voci spesso sfocate, belanti, scarse di volume e modeste di timbro. In taluni casi erano stati istruiti a cantare secondo uno stile di esecuzione che avrebbe dovuto, presumibilmente, riprodurre quello dei cantanti della prima metà dell’Ottocento. Alcuni risultati mi parvero risibili, né più né meno.
Sono passati più di quarant’anni da quei bei momenti di giovanile entusiasmo.
Ora ascolto con le mie orecchie e giudico in maniera totalmente autonoma. E, rileggendo quelle lontane recensioni, in diversi casi non mi trovo più d’accordo con Celletti.
Le recensioni dei critici in generale ora non mi interessano più.
Non mi interessa nemmeno più scambiare opinioni a teatro dopo le rappresentazioni perché, esprimendo semplicemente il mio pensiero, senza Celletti di mezzo, qualche tempo fa, ho perso un amico.
Tag: Norma
Tre millantatori all’Opera – Il soprano bolognese (Parte quarta)
Il venerdì successivo, sul tardi, ci saremmo dovuti incontrare per le prove.
Successe, però, che a metà del pomeriggio si levò un potente vento sibilante e gelido a cui seguì una nevicata memorabile come mai avevo visto. Nel giro di poco tempo tutta la città si trovò bloccata da quaranta centimetri di neve. La mia casa per diverse ore fu rischiarata dalle luci tremola, La neve proseguì per tutta la notte e il giorno successivo.
Telefonai con comodo a Tullio, a metà del mattino, tanto la vita in città era ghiacciata. Tirai un fiato di sollievo: avremmo fatto la rappresentazione dopo ben due settimane.
«Con un po’ di fortuna» pensai «il diavolo infilerà le corna un’altra volta».
Invece le forze del male non mi aiutarono e andammo in scena nella scuola di periferia secondo le previsioni.
Durante i quindici giorni che succedettero la nevicata ci vedemmo alcune volte. Tullio decise di sfrondare la Serva Padrona di molti bongiorno-bonasera, cioè dei recitativi. Pensando di possedere una grande vis comica, e perché lo spettacolo non durasse troppo poco, compensò i tagli con l’entrata di Don Magnifico dalla Cenerentola rossiniana. Il Barone di Montefiascone non si sarebbe rivolto a Clorinda e Tisbe, ma a me ed Evelina, fratellastro e sorellastra di Cenerentola, Tullio allora aggiustò i versi di Jacopo Ferretti in «Miei rampolli mascolini e femminini, vi ripudio; mi vergogno».
Provai la parte muta di Vespone con una passione proporzionale alle note che avevo da cantare. Conoscevo molto poco La Serva Padrona, avendola ascoltata dalla radio solo per quel tanto da essere pervaso di noia e cambiare il canale. Non intesi colmare le mia conoscenza dell’operina per avere dei riferimenti musicali conosciuti, così imparai l’azione e i movimenti di Vespone-Capitan Tempesta a pappagallo.
Venne finalmente il giorno della rappresentazione in una scuola al Fossolo, un sabato dopo l’Immacolata Concezione.
Ci attendevano in classe venticinque bambini educati e silenziosi, seduti compostamente davanti ai loro banchi, con indosso dei grembiulini lindi, stirati di fresco, bianchi e azzurri. Dagli sguardi curiosi e più attenti di quelli del pubblico in teatro, si percepiva che erano stati ben preparati all’ascolto dalla loro maestra, la mamma di Tullio.
Quest’attenzione mi emozionò. Si sarebbero meritati ben altro che la nostra orchestra, un registratore a musicassette appoggiato su di una sedia, e le nostre ingenue esibizioni mimiche e vocali.
L’aria di Rossini scorse via senza intoppi. All’attacco di «mie rampolli mascolini e femminini» Tullio fece il cenno di avvicinarci e ci spinse con forza a sedere per terra. E li rimanemmo. Cantò con delle belle castagne in gola, sottolineando i versi con gesti esagerati, come se avesse innanzi un pubblico di sordi.
Evelina, trovandosi a cantare in una stanza assai ampia e piena di gente, pareva più afona del solito. Nell’Intermezzo di Pergolesi entrambi si dimenarono, come sempre, con molta disinvoltura.
Fui io, invece, colui che creò l’intoppo nell’esibizione: come qualche settimana prima, andai nel pallone, dimenticando ogni cosa di quanto avevamo concordato durante le prove. Mi arrangiai ridendo come un deficiente con delle facce alla Jerry Lewis.
Non so se avvenne il consueto miracolo della Prima o se fu la fortuna che soccorre gli audaci, ma facemmo un gran successo. Al termine, i bambini accorsero tutt’intorno in festa offrendoci le delizie preparate dalle mamme, imbandite sulla cattedra della maestra prima che arrivassimo.
Mentre ci rimpinzavamo di torte di mele e al cioccolato, di pinza e ciambella pensai che non sarei mai salito su un palcoscenico con i finimenti di scena indosso. A proposito delle attitudini personali, mi venne in mente il mio professore di analisi I, al termine di un esame, quando espresse a uno studente di astronomia, con un’ efficace metafora musicale, un pensiero che lo riguardava:
«Lei mi ricorda un violinista a cui mancano le mani…Ora, non c’è nulla di male non avere le mani ma, almeno, non faccia il violinista»! Insomma,la matematica non gli si addiceva. Così detto, gli restituì il libretto senza il voto.
Il professore ebbe l’occhio fino poiché lo studente non si laureò e, dopo qualche tempo, prese a piatire per le strade del centro, a mani conserte, supplichevoli, con testa per traverso.
“La preeego, mi aiuuuti, ho faaameee, sono sfortunaaato, sono molto poooverooo”, faceva con voce che proveniva da naso.
«Anch’io sono un violinista senza mani» mi dissi mangiando gli ottimi dolci «il palcoscenico non è roba per me». Ma per questo non mi misi a mendicare.
Dopo le feste natalizie riprese il tran-tran dell’università. Mi trovai assai oberato di impegni e cose da fare perché dovevo seguire sia le lezioni universitarie che studiare per gli esami. Inoltre, devolvevo ancora qualche spicciolo di tempo libero per una moderata attività politica nell’ambito della Sezione Universitaria Comunista, la SUC, in quei giorni mobilitata per le conseguenze dell’orribile rapimento di Aldo Moro. Gli altri due, al primo anno di università, erano un po’ più liberi di me, non avendo ancora in programma alcun esame.
Di rappresentare L’Elisir d’amore in classe non se ne parlò più o forse fingemmo di dimenticarcene. Oppure perché ci sentivamo appagati dei nostri pomeriggi lirici.
Prima di conoscere Tullio ed Evelina non avevo mai pensato che la musica potesse diventare un gioco.
Il divertimento principiava con una telefonata
«Ti va una scantarellata»?
oppure
«Ci facciamo quattro strilli»?
Prendemmo gusto a duettare opere disparate, assecondando ì gusti personali di uno o dell’altro: cantammo Tosca, I Puritani, La Traviata, Rigoletto, Cavalleria Rusticana, La Boheme, La Gioconda, Otello, Il Trovatore, Il Barbiere di Siviglia, Norma, Nozze di Figaro… All’occorrenza io passavo con molta spavalderia dalla corda tenorile a quella baritonale.
Cantavamo in allegria, per divertirci, tra stonature, stecche e raspini.
Pure Evelina cantava senza remore né timori e, soprattutto, senza la bella voce della registrazione, né si sentì mai alcun suono che la ricordasse alla lontana.
Un giorno che mancò il soprano privo di voce ritornai nuovamente sulla questione della registrazione.
«Chi ti ha dato il nastro cantato da Evelina?», chiesi al mecenate di Evelina.
«Edmondo. Lo ha registrato lui».
Dall’espressione capii che la domanda non fu gradita. Una domanda inutile. Pensai che Tullio, trovandosi coinvolto in un amorazzo con Evelina, non si trovasse nella migliore condizione di ascoltare con obiettività.
Qualcuno mentiva. O Evelina, o Edmondo. E Tullio, sostenendo caparbiamente questa storia, dava il vigore della verità alla menzogna altrui.
Allorché conobbi Edmondo, lo pseudo ragazzo di Evelina – che pure era amico di Tullio – il loro triangolo alla Jules et Jim mi parve non solo una cosa fuori dalla norma rispetto ai tre soggetti, ma perfino una incomprensibile cosa, illogica.
Pensai:
«Questa ragazza è scema».
Oltre a non corrispondere in alcun modo alla corte della ragazza, si aggiungeva che Edmondo aveva veramente poco da spendere quanto a bellezza. Non che Tullio fosse un adone, ma Edmondo era proprio inavvicinabile. Come poteva pendere dalle sue labbra, contemplarlo e dirsi innamorata di lui? Aveva capelli radi, crespi, rossicci e sopracciglia unite, barba arancione a chiazze sempre di tre giorni, denti piccoli e giallastri. Non molto alto, stava in piedi con una postura ingobbita che gli faceva sparire il sedere e rientrare il petto. Sceglieva degli abiti dimessi dai colori sbiaditi, fra cui un eskimo salmastro, abiti che avrebbero intristito anche Alain Delon. Parlava con toni saccenti, una specie di grillo parlante con la erre mouillé.
Tullio riconosceva ad Edmondo una grande autorevolezza per ogni cosa. Ogni qual volta parlava del rivale-amico catechista, alzava le sopracciglia atteggiando la bocca a culo di gallina «Edmondo dice che…», «Edmondo ha fatto…», «Edmondo pensa che…». Edmondo di qua, Edmondo di là. Le registrazioni fatte da Edmondo erano le migliori. Aveva gusti musicali esemplari: Tullio odiava Wagner ma, poiché piaceva ad Edmondo, diventava il più grande musicista di tutte le epoche del mondo. Ci mancava solo che, riportando i discorsi dell’amico, concludesse con un grave «ipse dixit».
Era palese che non avrei scoperto tanto facilmente l’identità del soprano registrato e quindi, per quieto vivere, desistetti nel ricercare la verità.