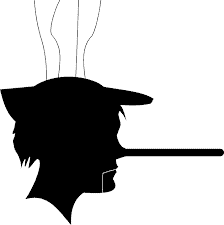Lessi di un episodio avvenuto al Caffè Florian di Venezia, non so in quale anno del boom economico. Un giovane direttore d’orchestra che avrebbe fatto una bella carriera incontrò, per caso, un corpulento signore oltre la settantina, dalla chioma bianca un poco scapigliata. In maniera esuberante raccontò di essere non solo un famoso tenore ma anche il rivale di Enrico Caruso al Metropolitan di New York. Disse di aver cantato con Arturo Toscanini.
“Ah, ah, ah! Lei lo conosce?» chiese il direttore d’orchestra al critico musicale che raccontava il fatto su una rivista, non ricordo se questi fosse Rodolfo Celletti o Giorgio Gualerzi.
«Ha detto che il suo nome è Giovanni Martinelli”, continuò mettendo implicitamente in dubbio la veridicità delle parole. Insomma un fanfarone da caffè di lusso.
Il signore «canuto» aveva raccontato, né più né meno, la verità.
Tenore lirico-spinto, gli americani consideravano Giovanni Martinelli l’erede del grande cantante napoletano, uno dei protagonisti della Golden Age del Metropolitan. Nacque nel 1885 a Montagnana, vicino a Padova, città assai fortunata quanto a tenori, poiché diciotto giorni dopo Martinelli nacque Aureliano Pertile.
La cosa paradossale di questo episodio fu che, narrando la verità, il celebre tenore passò per un pittoresco racconta frottole. Come non sapere chi fosse Giovanni Martinelli?
Sic transit gloria mundi.
Andando al Circolo Lirico Bolognese, soprattutto quando era nella sede di Palazzo Tanari vicino a casa mia, si incontrava una certa varietà di innocui gradassi. Spesso tenori che, a detta loro, avevano tutti voce da tenori spinti o drammatici. I ruoli erano Pollione, Manrico, Alvaro, Andrea Chenier, Turiddu, Canio, Calaf e Otello. A proprio dire, possedevano voci migliori sia di Franco Corelli che di Mario del Monaco. Le rare ed ovviamente deludenti esibizioni al Circolo Lirico si concludevano con complimenti sperticati davanti ma, dietro le spalle, tutti li derivano. Macchiette non completamente innocue.
Nell’ambito dell’opera, in pochi anni, ho conosciuto tre millantatori con i fiocchi, un soprano bolognese, un altro ferrarese e un tenore statunitense. Millantatori che costruirono le prove per dare veridicità alle menzogne.
Conobbi la prima millantatrice, quella bolognese, attraverso un vicino di classe del liceo con il quale non mi ero più visto da prima della mia Maturità. Era il 1977.
Entrambi collezionavamo dischi e opere dal vivo ma avevamo gusti musicali differenti: io ascoltavo dalla musica del romanticismo fino a quella contemporanea, Tullio si arrestava alla musica romantica. Adoravamo entrambi tre soprani, Magda Olivero, Montserrat Caballè e Joan Sutherland. Tullio, a differenza di me, non sopportava Maria Callas perché la sua voce ballava e gli acuti erano strillati.
Da quella conversazione uscì fuori che tutti e due cantavamo in casa sopra ai dischi come i matti del Circolo Lirico. Io tenore, lui basso.
Quando Tullio sentì questo gli si illuminarono gli occhi. Mi raccontò che faceva divulgazione lirica: essendo la madre maestra, Tullio cantava davanti ai bambini, mimando l’azione con costumi e qualche semplice oggetto di scena. Allevava una nuova generazione di frequentatori del melodramma. Non solo si esibiva personalmente ma aiutava la madre nello spiegare le opere ai bambini prima di accompagnarli agli spettacoli che il Teatro Comunale riservava alle scuole. L’ultima opera che i bambini avevano visto al Teatro Comunale fu Il Signor Bruschino diretto da Donato Renzetti, e tra i cantanti c’erano Saverio Durante, Silvia Baleani, Franco Federici e l’amico Floro Ferrari. Già in quegli anni si rilevava una crisi delle vocazioni liriche tra i giovani e tutto questo mi parve una piccola attività degna di qualche interesse.
Tullio, però, aveva in mente qualcos’altro. Quasi fosse un impresario, pensava di allestire una breve stagione lirica da rappresentare nella classe della madre: di lì a poco avrebbe messo in scena La Serva Padrona di Pergolesi. Era quasi pronta, aveva terminato le prove con il soprano, a suo dire molto bravo e con una voce bellissima. Una semiprofessionista. A Tullio mancava qualcuno che facesse Vespone, ruolo da mimo. E dopo l’opera di Pergolesi sarebbe venuto L’elisir d’amore. Per questa non aveva ancora trovato il tenore per il gravoso ruolo di Nemorino.
«Tu tenore? Splendido, ti scritturo. Puoi fare sia l’uno che l’altro».
Questa proposta non mi entusiasmò perché ben conoscevo la mia scarsa propensione ad apparire davanti al pubblico, seppur costituito da «cinni» delle elementari. Io ero un cantante che si esibiva in stanza da bagno, mica in una sala da concerto!
E poi, se adoravo L’Elisir d’amore, La Serva Padrona mi faceva addormentare. Tutt’ora con questo intermezzo mi faccio dei bei sonnellini.
La mia risposta fu, dunque, «no».
Ma Tullio non mollò. Ci eravamo, infatti, scambiati i numeri di telefono, e il giorno dopo mi telefonò: mi invitò a casa sua per due chiacchiere, qualcosa da mangiare, per vedere la sua collezione di nastri, ascoltare un po’ di musica. Infine per presentarmi Evelina, il soprano.
E andai.
Ascoltammo nastri, dischi e poi venne il turno di una registrazione di Evelina.
Ascoltammo È strano, Ah forse è lui, Sempre libera degg’io, un bel biglietto di presentazione.
Il brano aveva l’accompagnamento orchestrale. Tullio mi raccontò che il ragazzo di Evelina, caballeiano a trecentosessanta gradi, aveva trovato la base orchestrale dell’edizione completa diretta da Georges Prêtre senza, appunto, Montserrat Caballé.
Il soprano Evelina aveva una voce di timbro molto gradevole, ben emessa, agilità perfette e sciolte. Forse solo un po’ fredda come interprete, se proprio si voleva cavillare qualcosa. Non potetti che dire belle parole e, soprattutto, sincere.
«Accidenti…che brava. Sai una cosa? Mi ricorda la voce di Anna Moffo».
Nella registrazione di Evelina c’era anche il tenore fuori scena:
«È il maestro di Evelina, R.A., un tenore del coro del Comunale», mi spiegò il solerte ospite.
«Evelina canta a teatro?»
«No, è al secondo anno di architettura»
«Come l’hai conosciuta?»
«Ė la ragazza di un mio amico. Insegnano catechismo nella stessa Parrocchia»
«Ha fatto audizioni presso agenzie o teatri?»
«Per ora i genitori non hanno piacere e vogliono che prima si laurei»
Suonò il campanello e Tullio, con uno sguardo che dimostrava di essere al settimo cielo, portò Evelina in salotto a braccetto.
La voce aveva evocato altre fisionomie e un altro modo di essere.
La Diva indossava una pelliccia di lince ottenuta da animali in peluche. Magra, bassa ma con tacchi a spillo, portava dei jeans attillatissimi per metter in mostra il sedere. Mora corvina, una frangia leggermente crespa arrivava oltre le sopracciglia. Il volto terminava con un mento a punta, il naso aquilino spuntava da due zigomi sporgenti, labbra sottili, occhi scuri vivaci leggermente ravvicinati. Non era bella ma, come si dice, «un tipo».
Evelina aveva un carattere estroverso, rideva fragorosamente e con facilità. Parlava starnazzando con la pesante cadenza delle mie parti e poi le essce, le szeta, le tci bolognesi, che avrebbero decimato eleganza e fascino perfino a Grace Kelly.
(Continua)