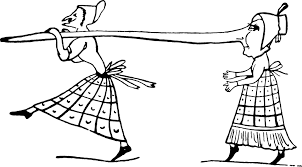«Tutto è politica».
Pure io così dicevo per mettermi in riga con i tempi ed anche per compiacere certi professori.
Verso il 1972 mi iscrissi al PCI, perseguendo una blanda attività politica. Blanda perché passiva. Passiva perché il Centralismo Democratico era ancora in pieno vigore. Vigore che si dimenticava dei giovani. Giovani che non avevano idee allineate.
Io non pensavo da allineato, cioè pensavo da non allineato, sentendomi spesso più vicino al Movimento Studentesco e agli Indiani Metropolitani che non al PCI.
Al primo anno di Università conobbi un polemico romagnolo della riviera, un tipo alto, corpulento. Antonio Di Russo, un mio compagno di Liceo fuori dai cliché, gli diceva in faccia che assomigliava a un porcellino. Il mio collega di facoltà pareva aver poca fretta d’arrivare alla laurea, evidentemente poco assillato da problemi economici. Ogni volta che lo incrociavo mi diceva di lasciare quella politica, il PCI e la sezione universitaria comunista. La SUC.
Nacque tra di noi un’amicizia di strada. Significava che tornavamo insieme dalle lezioni fino in centro. Oppure, lo incontravo per caso alla Libreria Feltrinelli in Piazza Ravegnana. Oppure, saltavamo le nostre lezioni per ascoltare insieme quelle di Umberto Eco al DAMS in Strada Maggiore e di Logica matematica in Piazza di Porta San Donato. Oppure, bighellonando, prima o poi ci si incrociava da qualche parte.
Dal punto di vista politico non ci beccavamo. Lo ritenevo un qualunquista perché evitava accuratamente di schierarsi per qualsiasi ideologia, criticando sia il PCI che il Movimento Studentesco. Guai mai, in quei giorni, non dichiarare la propria appartenenza politica: automaticamente si sarebbe stati qualificati come fascisti o, appunto, qualunquisti. Quasi fossero sinonimi.
Angelo non perdeva mai l’occasione di incitarmi ad allontanarmi dal PCI con un sorrisino irritante stampato sulle labbra.
«Durante le vostre riunioni la ‘Nadiona’ vi interroga per verificare se avete studiato a memoria L’Unità?». Una domanda che Don Camillo avrebbe potuto fare a Peppone Bottazzi. La ’Nadiona’ era la ragazza di un ‘compagno’ della mia facoltà. Tutti iscritti alla SUC.
«Perché butti via il tempo distribuendo i volantini del PCI?»
Arrivava con puntualità la frase:
«Tu non fai politica, sei il galoppino dei compagni e della Nadiona».
E qui mi arrabbiavo.
Ma i tempi non erano ancora maturi per abbandonare la SUC.
Dopo gli scontri studenteschi e i carri armati del 1977 non vidi più questo romagnolo. Seppi che aveva cambiato facoltà e si era iscritto al DAMS.
Passò qualche anno.
All’ora di pranzo del 3 gennaio 1983 telefonò un’amica di mia madre:
«Hai conosciuto all’Università Angelo Fabbri?»
«Certamente. Era un mio compagno di corso» risposi io, «Ma come fa a sapere di lui?»
«Ho letto sul Carlino che l’ultimo dell’anno è stato trovato morto in Val di Zena, dopo San Lazzaro di Savena. Ucciso con undici coltellate e buttato giù per una scarpata».
Sentii i brividi addosso. Mi infilai il cappotto e uscii di furia per comprare il Resto del Carlino.
Vidi la fotografia sul giornale: era proprio quell’Angelo Fabbri conosciuto da me, quell’Angelo che mi innervosiva con le sue scomode verità.
Al DAMS, in quei pochi anni, era diventato il migliore allievo di Umberto Eco. Scusatemi se è poco. Ed io che lo avevo considerato un perdigiorno!
«Tutto è politica».
Negli anni ’70 questa semplice frase, soggetto con predicato nominale, pervadeva come un mantra ogni persona di sinistra. Intellettuali sì, ma impegnati.
Nella testa le mie passioni frullavano in maniera diversa libere da suggestioni politiche e sociologiche come puro piacere.
Ma lo tenevo per me.
Le mie passioni di allora? Sostanzialmente quelle di ora: filosofia, musica, letteratura e arte.
Assecondando l’egocentrismo giovanile, facevo il verso alle opere dei grandi uomini, scrittori, filosofi e musicisti, a mano a mano che ne venivo a conoscenza. Non mi tiravo indietro dinnanzi a nulla e, poiché ero lettore e ascoltatore di musica insaziabile, avevo un bel daffare.
Liquido con indulgenza, e sbrigativamente, quelle cose: ragazzate che costituirono la formazione di un adolescente un po’ fuori dai canoni. Furono i miei ‘anni di formazione’.
Conosciuto Tullio, nel giro di pochi mesi rinnovai la mia vita: feci tante nuove amicizie, modificando al contempo ciò che non mi soddisfaceva, ovvero sparì l’attività politica, da modesto attivista di sinistra mi limitai ad essere cittadino che votava a sinistra, e lasciai perdere i balocchi da intellettuale. Insomma, i due fari esistenziali cresciuti durante il tempo del Liceo.
Così pian piano finirono nel nulla pure alcuni compagni di liceo con cui avevo condiviso i miei anni di formazione. Il primo, Silvio Nocenti, essendo disposto a firmare patti sia con dio che con il diavolo pur di blandire il proprio ego, si dileguò in autonomia perché non avrebbe saputo come utilizzarmi per i suoi scopi, essendo io un ‘piccolo uomo’ di scarsa utilità per perseguire i suoi piani. Nemmeno Antonio Di Russo era rimasto alla mia portata perché il suo senno se ne volò per sempre sulla Luna e non trovò qualcuno che, a cavallo di un ippogrifo, glielo riportasse indietro.
Alla bislacca Corinna Strocchi, la sola tra i miei compagni di liceo che aveva condiviso le mie passioni musicali, una delle persone che mi trascinò nel PCI, permisi invece di avere accesso alla mia ‘rinascita’.
Non è curioso che delle cose da me ritenute sciocche come le «scantarellate» del sabato – come le chiamava Tullio – abbiano contribuito a rivoluzionare la mia vita? Con l’età matura ho capito che le «scantarellate» furono invece un modo gioioso per seguire una passione molto seria, contribuendo a levarmi di dosso la bella e pesante coltre di pedanteria degli anni passati.
Alle «scantarellate» si unirono altri giovani appassionati d’opera lirica. Qualcuno si prendeva perfino la briga di salire su di un treno a Firenze e a Genova per unirsi a cantare insieme con noi!
Per diversi mesi Tullio mi aveva rotto le scatole parlandomi di un tal Rufo che studiava canto con Floriano Mantovani, un comprimario del Teatro Comunale. A detta di Tullio, Rufo possedeva una voce fenomenale. Non solo. Avrebbe potuto cantare l’intero repertorio tenorile, dai ruoli lirico-leggeri fino a quelli drammatici. Da Elvino della Sonnambula fino ad Otello, tanto per intenderci. Con tutto quello che stava in mezzo. Un tenore ‘quattro stagioni’, come gli armadi che contengono gli abiti sia per il caldo che per il freddo. Insomma il tenore che avrebbe fatto quadrare il cerchio in qualsiasi teatro e destinato a una luminosa notorietà.
I due si erano conosciuti al Teatro Comunale durante una fila al botteghino per acquistare i biglietti del Così fan tutte, prima opera in cartellone. Tutti i melomani accorsero perché Fiordiligi aveva la voce e la carne di Lella Cuberli, soprano la cui bravura era sottolineata dagli articoli di Rodolfo Celletti, re tra i critici d’opera. E noi giovani eravamo sudditi di questo dispotico re che, con un articolo, mandava al patibolo i cantanti che, per una ragione o per l’altra, non apprezzava.
Un giorno Tullio mi chiamò sovreccitato: Rufo lo aveva invitato a casa sua e gli aveva cantato l’ Esultate e Che gelida manina. Otello e Boheme!
«Ha una voce enorme, ti fa rifrullare le orecchie. Sembra quella di Franco Corelli!»
Strinsi fortemente la lingua tra i denti:
«Sì, adesso abbiamo anche Franco Corelli…ti piacerebbe. Bella gioia» pensai «anche Evelina secondo te doveva essere una grande cantante degna del Metropolitan…».
Interpretai che Tullio avesse detto quelle parole eccessive con l’intento di farmi rabbia, visto che anch’io ambivo ad essere un tenore ‘quattro stagioni’. Mi infastidiva perfino il nome.
Dicevo tra me:
«E poi che nome è Rufo? Rufo sta per rufus, rosso. Avrà i capelli rossicci come Edmondo. Ma ‘sti genitori, allora, non potevano battezzarlo come Fulvio?»,
Per diverse settimane Tullio continuò a tormentarmi questo Rufo.
«Sai, Rufo ha detto…Rufo ha fatto…»
È facile capire quanto questo Godot mi stesse antipatico.
E arrivò la settimana santa del 1980. Decisi di organizzare per il lunedì dell’Angelo e un pranzo in casa mia con qualche amico dell’allegra brigata lirica, Evelina, Edmondo, Corinna, Tullio, e Teresa, una farmacista mia partner di scantarellate.
La vigilia di Pasqua Tullio mi telefonò e, imprevedibilmente, chiese:
«Cosa ne dici se venisse a mangiare anche Rufo, quello che studia da tenore? Sarebbe una buona occasione per farti sentire da lui, dopodiché potresti andare prendere delle lezioni di canto dal suo maestro».
Tullio in genere mi irritava per la sua invadenza, però quella volta non fu così: si può immaginare quanto fossi curioso di ascoltare questo Rufo! Curioso come una scimmia. Quindi non rilevai più di tanto il giudizio implicito, ovviamente negativo, verso la mia voce.
In pomeriggio, Tullio passò da me per accordarci sul menù del pranzo. E si portò dietro Rufo che, a sua volta, portò con sé un amico, Gabriele, anche lui tenore ed allievo dello stesso maestro. Estesi l’invito anche i due tenori.
Ed accettarono.